CRONOBIOLOGIA, “JET LAG” E SPORT
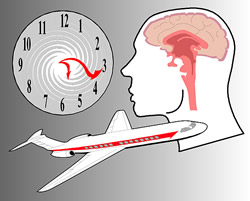
A cura del Prof. Mario Testi
Testo del Dott. Marcello Faina
(Per gentile concessione dell’autore)

CRONOBIOLOGIA E ATTIVITÀ SPORTIVA
Quando è meglio andare in palestra? La mattina, il pomeriggio o la sera? È evidente che nella maggior parte dei casi la scelta è dettata da tutti gli altri impegni (in genere lavorativi) ai quali bisogna sottostare. Tuttavia, qualora si possa scegliere, quale sarebbe la soluzione più opportuna? La mattina, quando si ha lo stomaco leggero e si è riposati; il pomeriggio, quando si è rifornito l’organismo di un po’ d’energia alimentare e si è superato il torpore del dopo sonno; la sera, quando il desiderio di relax rende più gradevole l’esercizio fisico?

In realtà ognuno di noi sceglie in un modo diverso, in funzione delle proprie caratteristiche e delle proprie sensazioni. Infatti, è, crediamo, un’osservazione usuale per ognuno quella di sentirsi meglio, più in forma, in certe ore del giorno piuttosto che in altre. Ci sono alcuni che carburano solo nel pomeriggio ed altri che invece hanno nel mattino il periodo più redditizio della giornata. Così come c’è chi preferisce dormire molto la mattina e far tardi la sera (i gufi) e chi si trova meglio con il comportamento contrario (le allodole).
Anche nell’attività sportiva si sente l’influenza della variabilità dell’efficienza fisica e psichica così che, a parte chi non può scegliere altrimenti, alcuni preferiscono gareggiare o fare sport in certi momenti del giorno piuttosto che in altri. Queste particolari situazioni, che hanno una spiegazione scientifica, in realtà per molti anni non sono state ben comprese, così come non si dava molta importanza a tutti i problemi che derivavano dai cambiamenti dei normali ritmi di vita. Basti pensare a coloro che lavorano in aziende a ciclo continuo e che quindi sono sottoposti a periodici cambi di turno, per capire quanto invece questi problemi siano importanti.
A dimostrazione della presenza nel nostro organismo di una specie d’orologio biologico, che quando è desincronizzato, quando cioè si crea una sfasatura tra questo e l’orologio esterno, è causa di una serie di notevoli problemi, basta ricordare il fenomeno del “Jet Lag”, che consiste nell’insieme di disturbi cui si va incontro quando ci si sposta dal proprio fuso verso gli altri fusi orari (andando in America, o in Giappone per esempio).
È la cronobiologia la scienza che insegna che l’uomo non è soggetto solamente al periodismo sonno-veglia, ma che numerosissime sono le funzioni organiche che procedono durante la giornata con alti e bassi del tutto codificati e non casuali.
La cronobiologia può interessare anche lo sportivo. Basta, infatti, ricordare il quesito di partenza: a che ora è meglio fare attività sportiva? Se non per rispondere alla domanda, almeno per avere le idee più chiare, è opportuno prima di tutto considerare in che cosa consiste questo cosiddetto orologio biologico.
Come detto, il nostro organismo sembra rispondere in modo differente secondo l’ora del giorno e sembra abbastanza chiaro che questa caratteristica è particolarmente regolare al punto che si ripete nello stesso modo ogni giorno. In questo caso si afferma che il ritmo biologico è di tipo “circadiano”, ha cioè una periodicità giornaliera, come l’alternanza sonno-veglia. Vi sono peraltro altri ritmi ed il più noto di tutti è certamente quello “circalunare”, tipico delle mestruazioni nelle donne, che durano una fase lunare e cioè quattro settimane.
Sono molte le funzioni che seguono un ritmo giornaliero. Una delle più importanti è il livello delle capacità psico-attitudinali come l’attenzione, la capacità cognitiva, la destrezza manuale e la coordinazione neuromuscolare. Queste capacità presentano il minimo nelle prime ore del mattino, ed il massimo nelle ore pomeridiane. Questo dato, di per se, è già un’indicazione a praticare sport “tecnici” nel pomeriggio!
Un altro parametro molto influenzato dal ciclo giornaliero è la temperatura corporea che ha il massimo alle quattro del pomeriggio ed il minimo alle sei del mattino, così come, circa, fa la frequenza cardiaca a riposo. Seguono sempre un ritmo circadiano altre funzioni biologiche come la produzione d’ormoni, la funzione respiratoria, la distribuzione delle cellule e dei liquidi nel sangue e così via.
La cronobiologia ha permesso di comprendere meglio il funzionamento dell’organismo, così come di adattare meglio alle sue caratteristiche gli eventuali supporti farmacologici o di programmare più correttamente l’attività lavorativa e quella normale di relazione.
Interessanti sono gli studi compiuti sull’alimentazione, per esempio, che hanno permesso di dimostrare come, avendo cibo a volontà, il soggetto non si alimenta a caso, ma segue un periodismo preciso. Al contrario, se il cibo è disponibile solo poche ore al giorno, il soggetto si adatta ad aver fame solo in quel periodo.
Come queste, molte altre sono state le osservazioni inerenti la cronobiologia che hanno dato utili indicazioni alla ricerca scientifica. Molto importante è per esempio il contributo dato dalla farmacologia. Infatti, conoscendo con quale ritmo all’interno dell’organismo sono prodotte le sostanze ormonali e non, è possibile impostare più correttamente le varie terapie.
A regolare in modo così preciso l’orologio del corpo provvede una speciale parte del nostro cervello denominata ipotalamo.

Peraltro questo timer ha bisogno di un continuo controllo e di una continua regolazione da parte di segnali di riferimento esterni. Sono, infatti, ben pochi i meccanismi biologici che seguono il proprio ritmo qualsiasi cosa accada nel mondo esterno. La maggior parte di loro, al contrario, ha bisogno di continui aggiustamenti.
Il principale segnale esterno di riferimento è proprio rappresentato dal susseguirsi dei giorni e delle notti e quindi dell’alternarsi del sonno con la veglia.
A dimostrazione di ciò basti pensare a quelle persone che, a scopo di studio o altro, si “esiliano” per lunghi periodi in profonde grotte senza più cognizione della luce. Ebbene questi soggetti automaticamente perdono il ritmo normale delle 24 ore per acquisirne uno nuovo del tutto speciale. La perdita del sonno rappresenta quindi un elemento di disturbo notevole nel normale ritmo di funzionamento biologico dell’organismo. Da ciò derivano una serie d’alterazioni che possono inficiare in modo significativo la prestazione sportiva, quando questa avviene, per esempio, dopo una notte passata insonne.
Ma quali sono le conseguenze legate alla perdita del sonno? La principale fra loro sembra sia legata alla riduzione delle capacità psico-attitudinali ed in particolare del livello di stimolazione nervosa e della coordinazione neuro-motoria. Altri fattori alterati possono essere la frequenza cardiaca di base (che si abbassa), la concentrazione di glicogeno nei muscoli, specie quelli posturali che non si riposano a letto (anche questa ridotta), la forza muscolare. Minor accordo c’è da parte dei vari autori sull’andamento del quadro ormonale ed in particolare degli ormoni più importanti per la reattività dell’organismo all’ambiente esterno, come il cortisolo, l’adrenalina, la tirosina etc.
La perdita di sonno ha anche effetti psicologici che secondo alcuni sono dimostrati dalle occasionali perdite d’attenzione, considerate come piccole crisi di sonno (micro-sleep) della durata di pochi secondi.
Come si vede, sono molti i fattori che sono coinvolti da una notte passata in bianco, anche se la maggior parte degli autori sono propensi a pensare che gli effetti peggiori, anche sulla capacità di prestazione, sono dovuti essenzialmente all’intorpidimento delle capacità di risposta del sistema nervoso centrale agli stimoli esterni. Ciò causa, infatti, la perdita della precisione nei movimenti quando questi sono continuamente variabili (come negli sport di squadra o nelle situazioni di gruppo) oppure di rallentamento quando sono invece monotoni e ripetitivi. Si capisce bene come in una situazione di questo tipo fare esercizi che richiedono grande attenzione per la tecnica d’esecuzione o per l’uso d’attrezzi, può risultare assai più complicato ed in alcuni casi anche non scevro da rischi.
Un altro aspetto legato alla riduzione delle capacità neuro-muscolari è l’aumento del costo energetico del gesto atletico. Ciò è dovuto al fatto che il soggetto stanco ed assonnato non riesce più a muovere i propri muscoli con la coordinazione abituale e così per fare lo stesso sforzo consuma molta più energia.
Cosa si deve dedurre da queste parziali indicazioni?
Certamente la prima considerazione porterebbe ad invitare tutti ad astenersi da tali pratiche ed a godersi il meritato riposo notturno così come madre natura ha previsto.
Dal punto di vista del gesto atletico, considerato lo scadimento delle capacità neuro-motorie, gli accorgimenti più opportuni sono quelli di evitare prestazioni o gare che richiedono elevati livelli d’attenzione, prontezza di riflessi esasperata, velocità di movimenti; mentre sono da preferire quelle situazioni nelle quali i gesti sono semplici, eseguiti a bassa velocità sia di movimento che di corsa (anche se non troppo da risultare noiosi) e che comunque non rischiano di mettere in condizioni di pericolo, per qualche pausa da micro-sleep, né lo sportivo stesso, né i compagni. Vanno bene, per esempio, in palestra le attività di sviluppo della fitness cardiovascolare, mentre meno consigliabili sono i lavori con i pesi o macchine per lo sviluppo del tono-trofismo muscolare. Questi ultimi non tanto per il materializzarsi d’eventuali fattori di rischio, quanto per la minore efficacia.
I RITMI CIRCADIANI E LA “JET LAG”: Considerazioni e Consigli per gli Sportivi

Circa quaranta anni fa alcuni ricercatori francesi, studiando i livelli di escrezione del potassio con le urine, scoprirono che questi seguivano un ritmo regolare il cui ciclo era di circa 24 ore. Gli esiti di questo studio concordavano con quelli di altri ricercatori ed il quadro che ne venne fuori è che, al contrario di quanto si pensava fino ad allora, la quasi totalità delle funzioni umane (ad esempio la produzione ormonale, l’andamento della temperatura corporea, della pressione arteriosa, del battito cardiaco, dell’umore) ha un andamento ritmico. Sulla base di queste prime osservazioni è nata la cronobiologia, scienza che studia la variazione nel tempo (ritmica) delle funzioni biologiche.
La maggior parte dei ritmi biologici ha un andamento sinusoidale, come avviene per le variazioni della temperatura corporea nelle 24 ore. I ritmi con un periodo compreso tra le 20 e le 28 ore vengono definiti circadiani. Quelli con un periodo inferiore alle 20 ore, come da esempio le fasi del sonno, vengono definiti ultradiani. I ritmi con un periodo superiore alle 28 ore si chiamano infradiani; tra questi ultimi va ricordato il ciclo mestruale che avendo una durata pari a quella del ciclo lunare viene definito “circalunare”.
Focalizziamo la nostra attenzione sui ritmi circadiani. Come detto, questi sono i ritmi che hanno un andamento sinusoidale che si completa (inizio e fine del ciclo) in un tempo compreso tra le 20 e le 28 ore. Molti sono i parametri biologici studiati in medicina che presentano un ritmo circadiano, con momenti, nell’arco delle 24 ore, di massima (acrofase) e di minima espressione (più o meno dopo 12 ore). Anche quelli di più comune ed insospettabile rilievo nella medicina classica, come l’emocromo, possono variare a seconda dell’ora nella quale vengono studiati.
Ci si è domandato cosa regola nell’organismo l’andamento dei cicli. La risposta è stata trovata sia all’interno di esso che all’esterno. Si è infatti osservato che i ritmi circadiani sono regolati da una sorta di orologio biologico, localizzato in una struttura del sistema nervoso centrale denominata ipotalamo.

Infatti essi persistono inalterati quando un individuo viene posto in condizioni ambientali costanti (es. grotta naturale) e richiedono tempo per adattarsi alla nuova situazione dopo un viaggio transmeridiano che attraversa i cosiddetti fusi orari.
Tuttavia è stato osservato che anche stimoli esogeni, cioè esterni all’organismo, possono alterare i ritmi circadiani. Il più importante tra questi è l’alternarsi del giorno e della notte, cioè della luce e del buio, che condiziona tutte le abitudini della società umana. In tal senso basta soffermarsi sul fatto che la maggior parte delle attività dell’uomo moderno si svolgono di giorno quando c’è luce e la temperatura ambiente è più elevata.
Ad ulteriore dimostrazione dell’influenza dei fattori esogeni basta ricordare la desincronizzazione e la successiva risincronizzazione dei ritmi circadiani dopo un cambiamento di fuso orario. Ciò prova che l’orologio biologico è essenzialmente sincronizzato sull’alternanza di luce e buio.
L’andamento del ritmo circadiano “dell’umore”, di un individuo, mostra come lo stato d’animo migliore coincida con le ore pomeridiane e serali.
Ciò può avere notevole importanza nello sport in quanto aumenta la predisposizione all’attività fisica di un soggetto incidendo positivamente sulla componente motivazionale.
Proprio per quanto riguarda la capacità di prestazione sportiva è interessante notare che anche per questo parametro esiste una ritmicità circadiana; ciò è testimoniato dal fatto che la maggior parte dei record sono ottenuti nelle prime ore serali.
Questa ritmicità in parte può essere attribuita al fatto che la maggior parte delle gare si svolgono di sera per esigenze commerciali (televisive) ed in parte ai fattori ambientali che, soprattutto l’estate, sono più favorevoli in queste ore del giorno. Si tratterebbe in questo caso di una ritmicità non legata all’orologio biologico.
D’altra parte si pensa che una delle ragioni delle “performance serali” vada individuata nel ritmo circadiano della temperatura corporea che ha i suoi valori più alti in questa fase della giornata.
Che esista una ritmicità biologica circadiana della capacità di prestazione atletica è confermato dai risultati di una serie di test di laboratorio condotti sugli stessi soggetti in momenti diversi della giornata.
Questi test hanno messo in evidenza, ad esempio, che:
1) il tempo di reazione a stimoli visivi o uditivi presenta un picco nel tardo pomeriggio in corrispondenza dei massimi valori di temperatura corporea. Una spiegazione può essere ricercata nel fatto che per ogni grado centigrado (°C) di aumento della temperatura la velocità di conduzione nervosa aumenta di 2,4 m/s.
2) Il massimo livello delle capacità cognitive e di lavoro intellettuale, nonché la precisione del gesto, si registra al mattino. Ciò condiziona favorevolmente gli sport in cui è importante la destrezza e gli sport ad elevata componente tecnico-tattica.
3) La forza esplosiva e quella massimale presentano il livello più alto nel periodo compreso tra le 16 e le 18; altrettanto dicasi per la mobilità articolare.
4) Anche le capacità metaboliche, sia aerobiche che anaerobiche, risultano più elevate nel tardo pomeriggio quando si notano i valori massimali di consumo di ossigeno, di ventilazione polmonare, di gittata sistolica e di portata cardiaca. In questa fase della giornata risulta più elevata la resistenza di un atleta ad un lavoro costante ad alta intensità, nonché la capacità di produrre lattato.
Questi dati appaiono confermare i rilievi indiretti sul campo che evidenziano come la sera sia il momento della giornata più favorevole alle performance agonistiche.
Un altro problema fondamentale, strettamente connesso all’esistenza dei ritmi circadiani, è il cambiamento di fuso orario.
Trasferirsi da un continente all’altro costringe i soggetti a mangiare ad ore diverse da quelle alle quali è abituato e, principalmente, a cambiare l’ora di “addormentamento” e di risveglio. Egli avrà la sensazione che il suo giorno si sia allungato quando si sposta verso ovest (per esempio andando in America) e che, invece, si sia accorciato andando verso est (Australia).

Il cambiamento di fuso orario provoca la desincronizzazione dei ritmi circadiani che manifestano un’inerzia ad adattarsi alle nuove alternanze di luce e di buio. Da questo punto di vista non è la stessa cosa allungare od accorciare il giorno. È infatti dimostrato che spostandosi verso est (oriente) è necessario il 50% in più di tempo per riadattarsi rispetto a quando si va verso ovest (occidente). Per esempio cambiare il proprio fuso orario di 12 ore verso ovest necessita di 6 giorni di risincronizzazione, mentre se le stesse 12 ore vengono cambiate andando verso est i giorni diventano 9.
Appare quindi evidente che quando il cambiamento di fuso orario è di 10-12 ore, quindi in altri termini ci si trasferisce dalla parte opposta della terra, è opportuno viaggiare da Oriente ad Occidente.
Questa differenza è legata al periodo naturale di ritmi circadiani che per la maggior parte delle funzioni vitali supera le 24 ore. È perciò più facile per un individuo “allungare” la sua giornata trasferendosi verso ovest, che “accorciarla” verso est.
In campo sportivo queste considerazioni sono molto importanti in quanto, com’è facile immaginare, quando si devono programmare le trasferte in altri continenti, vanno tenuti presenti, oltre agli aspetti squisitamente tecnici (conoscenza del campo e delle condizioni di gara, rifinitura dell’allenamento), anche i tempi necessari per riportare l’organismo nelle migliori condizioni funzionali.
Da quest’ultimo punto di vista la durata del processo di risincronizzazione può variare da 1-2 giorni a 7-10 e più giorni e dipende da tanti motivi, in particolare:
- dalla distanza del viaggio (l’adattamento dell’organismo al cambiamento di fuso orario di 3-4 ore può avvenire facilmente, invece un cambiamento di fuso orario di 6-8 ore richiede un periodo abbastanza lungo)
- dalla direzione del trasferimento (l’atleta sopporta meglio il trasferimento da oriente ad occidente)
dal regime di vita nel periodo che precede il trasferimento (una preparazione anticipata, variando già in patria le abitudini, può facilitare notevolmente il processo di risincronizzazione) - da una alimentazione razionale prima, durante e dopo il trasferimento
- dall’uso di mezzi a procedure speciali (assunzione di sonniferi, applicazione di misure fisioterapiche e psicologiche tranquillizzanti)
- dalla specificità dello sport considerato (il processo di risincronizzazione negli sport caratterizzati da una struttura di movimenti piuttosto semplice e da un carattere monotono dell’attività di allenamento avviene più rapidamente)
- dalla difficoltà delle azioni motorie (la sincronizzazione dei ritmi delle azioni semplici, della forza statica, del tempo di reazione semplice, della frequenza dei movimenti-standard, avviene più rapidamente rispetto a quella delle reazioni complesse, specialmente in situazioni che variano)
- dal carattere dell’attività di allenamenti e di gara che precede il trasferimento (la velocità di adattamento al cambiamento di fuso orario degli atleti che partecipano spesso a gare in continenti diversi, costretti quindi ad allenarsi nei diversi periodi della giornata, è più elevata).
Per quanto riguarda la preparazione anticipata al trasferimento, il cambiamento graduale della vita quotidiana e dell’attività sportiva possono sollecitare, come detto, il processo di adattamento.
Molti atleti cambiano l’orario delle sedute di allenamento e quelle delle abitudini di vita a partire da 10-15 giorni prima di un trasferimento; ciò facilita il cambiamento dei ritmi circadiani secondo le condizioni ed il luogo delle gare e favorisce la risincronizzazione delle funzioni biologiche una volta giunti a destinazione.
Per quanto riguarda l’alimentazione un’approccio razionale al problema può contribuire ad una più rapida risoluzione della sindrome da Jet lag.
Ad esempio, se nel caso di trasferimento verso occidente (dall’Italia verso l’America), si prevede un arrivo al mattino, sarà opportuno consigliare agli atleti di consumare, fin dalla partenza e durante il volo, bevande nervine (caffè, the, coca cola ecc.) e cibi ricchi di proteine, in grado di favorire lo stato di veglia, contribuendo così a predisporre l’organismo ad una condizione di attività e quindi alla “situazione sociale” del luogo di destinazione.
Al contrario, nel caso di arrivo nel tardo pomeriggio – sera, sarà necessario predisporre l’organismo degli atleti al riposo notturno e pertanto i carboidrati, segnatamente quelli amidacei (pasta, riso, pane, ecc.) dovranno rappresentare, in questo caso, la quota parte maggiore dalla razione alimentare da consumare in viaggio, poiché in tal modo si favorirà la produzione endogena nel cervello di una sostanza (la serotonina) in grado di “sedare” l’organismo e favorire il sonno.

Inoltre i carboidrati amidacei, ricchi di acqua, contribuiscono al rifornimento idrico durante il viaggio in aereo, il cui microclima (più secco del normale per l’aria condizionata) induce una maggiore perdita di liquidi per incremento delle perspiratio insensibilis, cioè attraverso il vapore acqueo presente nell’aria espirata dai polmoni.
A tale proposito si sottolinea l’opportunità di fare frequente uso di bevande durante il volo; nel contempo vanno tuttavia evitate tutte le bevande alcoliche (l’alcol non disseta e favorisce la disidratazione!) e drasticamente limitate quelle cosiddette “nervine” (caffè, tè, prodotti a base di cola, ecc.) per il loro effetto stimolante sul sistema nervoso centrale, che contrasta con l’auspicabile predisposizione fisiologica al sonno una volta giunti a destinazione.
In ogni caso, comunque, dopo il primo pernottamento in sede, si dovrà prevedere un elevato apporto proteico (formaggi magri, prosciutto, latte, yogurt, uova, cereali, ecc.) ed una buona dose di tè o caffè per sfruttare al meglio l’effetto stimolante della caffeina e delle proteine legate anche alla produzione di catecolamine, ormoni particolarmente attivi nell’azione di “eccitamento”.
Questo accorgimento potrà favorire il ripristino del ritmo sonno-veglia, accelerando il superamento dello stress da fuso orario.
Dal punto di vista del ripristino del ritmo sonno-veglia, dopo un trasferimento verso ovest con un cambiamento di fuso orario di 5-8 ore, se non si è dormito durante il volo e quindi ci si è posti in una condizione per cui il riposo notturno “ritarda”, ci si addormenta abbastanza bene per la prima notte mentre nei 2-3 giorni successivi sono possibili risvegli per una certa insonnia. La struttura del sonno si normalizza entro 2-4 giorni.
Nel caso di un viaggio verso est i disturbi del sonno sono più profondi e di maggiore durata (5-6 giorni). Di solito questi trasferimenti avvengono di notte e quindi, se si evita di addormentarsi durante il volo e, soprattutto, appena giunti a destinazione, il sonno profondo nella prima notte dopo il trasferimento diviene più facile.
Nei giorni successivi, tuttavia, ci si trova di fronte a difficoltà maggiori ed all’insonnia.
Per facilitare la sincronizzazione del ritmo sonno-veglia possono essere assunti sonniferi le prime 2-3 notti dopo un viaggio verso ovest e le prime 3-5 notti dopo un viaggio verso est.
È interessante, da quest’ultimo punto di vista, l’effetto dell’uso la sera tardi della melatonina, un ormone che viene prodotto da una particolare struttura del cervello (l’epifisi), ed oggi facilmente reperibile in commercio.
L’assunzione di questa sostanza non solo riduce i disturbi del sonno ma sembra favorire anche la risincronizzazione dei ritmi circadiani dell’organismo.
La melatonina, oltre ad altri effetti, che non è questa la sede per illustrare, ha avuto una grande diffusione prima di tutto tra le persone sottoposte, per lavoro, come i piloti, a frequenti cambiamenti di fuso e successivamente anche a chi necessitava di ridurre al minimo i tempi di risincronizzazione ed i disturbi legati all’alterazione del ritmo sonno-veglia.
In conclusione, queste brevi note sui ritmi biologici, se non esauriscono l’argomento (e non potrebbero), credo possano far ben comprendere perché, ciascuno di noi “si senta” meglio di mattina oppure di sera, perché alcuni rendono di più la notte (i GUFI) ed altri la mattina (le ALLODOLE). Tutto è scritto nel nostro codice e l’organismo non fa altro che dimostrarci quanto sia complesso il suo funzionamento.
**





















