IMPORTANZA DELLE PERCEZIONI DI AUTOEFFICACIA ED EFFICACIA COLLETTIVA NELLA PREVENZIONE DELL’ABBANDONO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
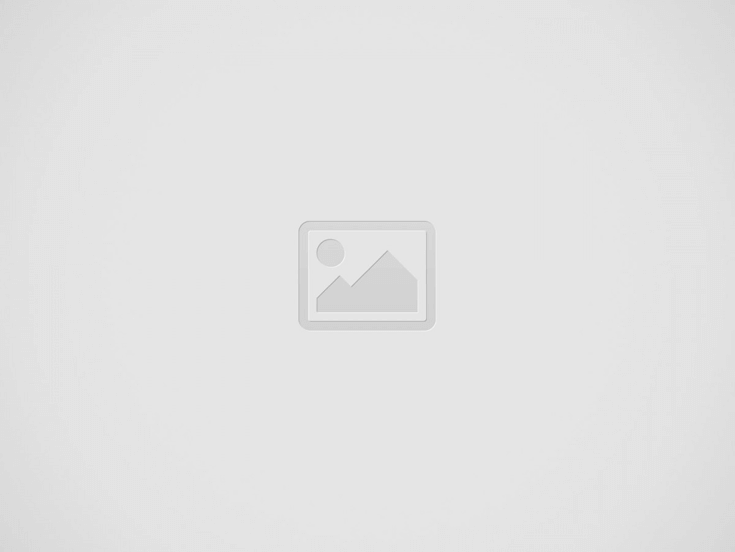

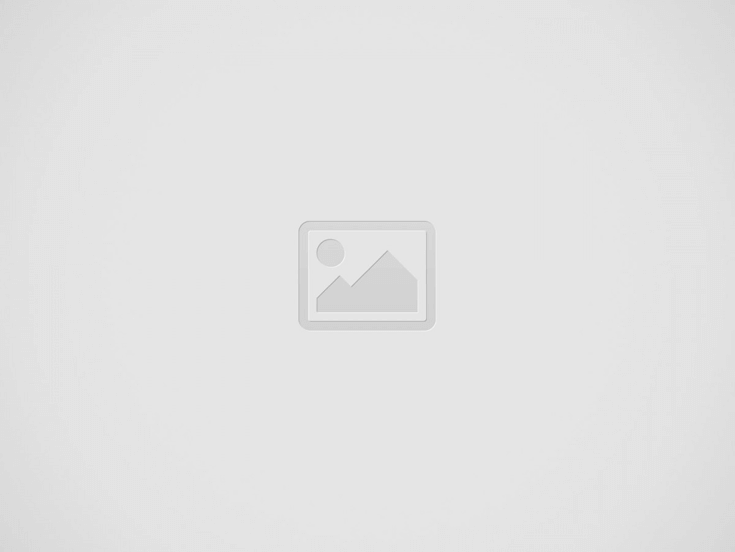

Introduzione
Eppure il “sistema sport” per la sua crescente importanza, le sue interazioni con altri aspetti rilevanti della vita sociale (politica, media, marketing) può essere assunto a specchio dello sviluppo stesso di un paese: non è certo un caso che tutti i Paesi, da quelli sviluppati a quelli in via di sviluppo, indipendentemente dalla loro struttura politico-economica, rivolgano sempre più risorse al potenziamento della pratica sportiva e dell’attività fisica. I motivi di queste scelte vanno ricercati nei valori connessi alla pratica sportiva, nel ruolo svolto dall’associazionismo, nella loro importanza ai fini della prevenzione della salute, nella ricerca del benessere psicofisico, nella crescente fruizione della cultura e del tempo libero in tutti i modelli di società, per finire, ma non certo per ordine di importanza, nel rilevante peso economico che lo “sport-azienda” ha nello sviluppo stesso di un paese. Certo è proprio per questo ultimo aspetto che in molti paesi, tra cui l’Italia, lo sport, soprattutto quello a livelli professionistici, non riesce a liberarsi di pesanti fardelli: il prevalere degli aspetti legati al business rispetto a quelli educativo-formativi e la monocultura del calcio, l’allarme doping, per fare degli esempi (D’Arcangelo, 2005).
Spesso tutti questi aspetti divengono più centrali ed importanti della salute psico-fisica di chi lo sport lo pratica e lo ama, spostando l’attenzione dall’atleta, dai suoi bisogni e dalle sue percezioni, e concentrandola sul sistema-azienda sport che deve produrre talenti per aumentare il business delle iscrizioni ed ottenere visibilità mediatica.
Come sottolineato da Bandura (2000a), il successo nelle competizioni atletiche non richiede solo abilità di tipo fisico. Per ammissione comune, i fattori cognitivi svolgono un ruolo molto importante nello sviluppo e nel funzionamento atletico. Gli atleti devono lavorare duramente ed a lungo per padroneggiare le abilità richieste dal loro sport e per tenere duro di fronte agli ostacoli e alle difficoltà. Le convinzioni di efficacia atletica consentono di prevedere chi sceglierà di intraprendere certe attività sportive ed in che misura queste persone miglioreranno le loro abilità partecipando a programmi di allenamento. Benché, gli atleti che riescono a superare il processo di selezione, di per sé altamente competitivo, possiedono un talento naturale per l’attività sportiva prescelta, gli è richiesta anche una forte e radicata motivazione per affrontare il processo lungo ed impegnativo di continuo perfezionamento. Quando ci si trova a dover affrontare e competere con avversari molto capaci, l’eventuale perdita o sconfitta può dipendere da un breve calo di attenzione, di impegno o precisione. Non sorprende quindi che negli ambienti sportivi si riconosca da molto tempo l’importanza di un saldo senso di efficacia per una prestazione ottimale. In condizioni di forte pressione competitiva, per eseguire efficacemente le abilità apprese, gli atleti devono esercitare un controllo sugli effetti inabilitanti degli stressor acuti, dei cali di motivazione, degli insuccessi scoraggianti e del dolore fisico intenso. Il successo di tali sforzi di autoregolazione dipende in larga misura da un senso di efficacia personale resiliente.
Non devono essere prese in considerazione, quindi, le sole variabili connesse con la fatica e la preparazione fisica, ma tutti quegli aspetti connessi con le percezioni di autoefficacia ed efficacia collettiva dell’atleta che influiscono direttamente sulla qualità della sua prestazione e sulla sua motivazione ad intensificare gli sforzi e persistere nell’attività sportiva.
La Teoria sociale cognitiva di A. Bandura (1986, 1997), riconosce all’azione umana (human agency) un ruolo inscindibile da quello dell’ambiente e dal pensiero nella costruzione della personalità e nello sviluppo dell’individuo. Le persone operano delle scelte, motivano e regolano il proprio comportamento sulla base di un sistema di credenze.
Tra i meccanismi di autoregolazione nessuno è più importante o pervasivo delle convinzioni di efficacia personale. L’autoefficacia è definita come il grado di controllo che le persone ritengono di poter esercitare nei vari ambiti nei quali si declina la loro esistenza (Bandura, 1997). Se le persone non sono convinte di essere in grado di ottenere i risultati desiderati e prevenire quelli indesiderati tramite le loro azioni, avranno scarsi incentivi ad agire o a continuare a battersi anche di fronte alle difficoltà (Bandura, Locke, 2002).
E quando l’atleta opera all’interno di una squadra, che sia costituita da due o più elementi, si deve ampliare il concetto di intervento umano prendendo in esame anche quello di intervento collettivo e la conseguente percezione di efficacia collettiva (Bandura, 1997; 2001). Essa è definita come “la convinzione condivisa di un gruppo riguardo alla capacità congiunta di organizzare ed eseguire corsi d’azione necessari per realizzazioni di vario livello” (Bandura, 2000a, p.640).
L’efficacia collettiva percepita accresce la visione delle persone riguardo a quanto desiderano ottenere, rafforza la motivazione nel perseguimento della propria missione, intensifica la resistenza alle avversità e rafforza i successi della propria prestazione (Bandura, Locke, 2002).
Tale costrutto trae origine sia dalle convinzioni di efficacia personale che dalle percezioni soggettive del contesto nel quale l’individuo si trova ad operare (Borgogni, 2001). Di grande importanza è, quindi, anche la nozione di clima definita come l’insieme delle percezioni, rappresentazioni ed atteggiamenti che sorreggono e contraddistinguono i rapporti all’interno di un contesto lavorativo, aziendale o sportivo (Quaglino, 1995; Quaglino, Mander, 1987).
Studi recenti (Kaz-Navon, Erez, 2005), hanno inserito tra gli antecedenti dell’efficacia collettiva anche l’interdipendenza del compito corrispondente al livello di interazione richiesto ai membri di un gruppo per svolgere un compito (Bandura, 1997). È emerso infatti che se gli individui si ritrovano ad interagire e coordinarsi tra di loro in modo interdipendente, è più probabile che diano vita a percezioni simili sulla loro efficacia collettiva (Katz-Navon, Erez, 2005).
Motivazione all’abbandono e motivazione a perseguire nell’attività
Ogni anno numerosi giovani decidono di abbandonare la pratica sportiva e, molto probabilmente ciò avviene perché essi “non trovano soddisfatti i bisogni che li avevano inizialmente spinti ad intraprendere l’attività” (Cei, 1998). Si tratta di un problema cruciale al quale è necessario far fronte, nella misura in cui l’abbandono precoce è frequentemente vissuto come un insuccesso per gli atleti e gli addetti ai lavori (Benedetti, Landi, Merola 2006).
L’attività sportiva richiede all’atleta un impegno consistente e, secondo Cei (1998), l’individuazione e l’analisi dei motivi che determinano il coinvolgimento sportivo, costituisce l’apporto più concreto che la psicologia dello sport può fornire.
Negli anni ‘70 uno studio condotto da Alderman e Wood (1976) su giovani atleti canadesi, ha evidenziato che: l’affiliazione, intesa come opportunità di stabilire relazioni interpersonali significative, lo stress, la possibilità di svolgere attività eccitanti, l’eccellenza, l’acquisizione di abilità sportive per primeggiare su qualcuno o per proprio interesse, ed il successo per acquisire status-prestigio-approvazione da parte degli altri, sono i principali motivi alla base del coinvolgimento in una disciplina sportiva.
Altri autori, Gill, Gross e Huddleston (1983), ritengono che le motivazioni più importanti all’attività sportiva riconosciute dai giovani atleti rispondono a bisogni specifici, bisogni delineati da Martens (1987) nel modo seguente: a) divertimento, inteso come bisogno di stimolazione ed eccitamento; b) competenza, bisogno di acquisire abilità motorie e di sentirsi autodeterminati nell’attività svolta; c) affiliazione, bisogno di stare con gli amici o farsene nuovi, bisogno di far parte di un gruppo/squadra.
Mancanza di divertimento, carattere troppo serio degli allenamenti, mancanza di successo, stress da competizione, assenza di appoggio da parte dei genitori e/o allenatore e noia sono, invece, i fattori maggiormente responsabili dell’abbandono in età evolutiva (Benedetti, Landi, Merola 2006). Queste ragioni sembrano relativamente indipendenti dalle discipline praticate: i motivi d’abbandono sono approssimativamente gli stessi nel nuoto (Gould et al., 1982; McPherson et al., 1980), nel calcio (Pooley, 1981), o nell’insieme delle discipline quali lo sci di fondo, l’hockey su ghiaccio, calcio, baseball, nuoto (Orlick, 1973).
I risultati emersi dalle ricerche condotte in questo campo ci parlano di un forte legame tra le motivazioni alla pratica sportiva e l’età: l’abbandono, nei bambini più piccoli, è generalmente attribuibile al carattere serioso della pratica, all’insufficienza delle relazioni amicali ed alla mancanza del lavoro di squadra (Gould et al., 1982; Pooley, 1981; Sapp e Haubenstricker, 1978). Le motivazioni che caratterizzano i bambini tra gli 8 ed i 10 anni, secondo Cei (1998), sono le seguenti: “trarre piacere dall’azione sportiva, muoversi pensando, sapersi assumere dei rischi calcolati e saper vivere in gruppo”. Tra i 10 ed i 12 anni di età, sono il piacere del gioco ed il divertimento, le dimensioni maggiormente ricercate nello sport, così come il progresso nella padronanza delle abilità sportive. In seguito si produce una diversificazione dei centri d’interesse e le motivazioni diventano più eterogenee. Lo sport viene vissuto come mezzo per la promozione sociale e per raggiungere sempre più alti livelli di partecipazione. Aumentano le occasioni di confronto e competizione e si ricercano allora maggiormente relazioni con gli altri membri della squadra: la collaborazione con i compagni e lo svilupparsi di un senso di appartenenza al gruppo sportivo divengono elementi centrali del coinvolgimento del giovane alla pratica sportiva, strettamente correlati con la percezione di sentirsi competente (Benedetti, Landi, Merola 2006).
Duda e Whitehead (1998), sottolinearono, inoltre, che la motivazione tende a diminuire se i tentativi dell’atleta di gestire l’ambiente vengono frustrati o puniti, e/o vengono invece rinforzati i comportamenti di dipendenza dagli adulti.
La motivazione è una “variabile determinante del comportamento insieme all’abilità, alle conoscenze ed ai vincoli situazionali” (Borgogni, 2002) e può essere definita come uno degli aspetti più importanti per l’individuo perché ne attiva, dirige e sostiene l’azione per il raggiungimento di uno specifico obiettivo. La motivazione rappresenta un fattore determinante che incide direttamente sull’impegno investito nel lavoro, a sua volta il grado di impegno profuso è direttamente correlato con il valore attribuito agli obiettivi e la percezione di autoefficacia posseduta dal soggetto, ovvero quanto si sente in grado di organizzare e dirigere le sue abilità e risorse per attuare un’azione che lo condurrà alla conseguenza desiderata. In particolare, l’autoefficacia non riguarda il numero di abilità possedute, ma ciò che si crede di poter fare con i mezzi a propria disposizione, non è una percezione generalizzata, ma è compito-specifico e varia da situazione a situazione, non è un predittore passivo delle prestazioni future, ma si ripercuote sui processi di pensiero, sul livello e la persistenza della motivazione e sugli stati affettivi (Bandura, 1977).
Modello Teorico di Riferimento
La teoria sociale cognitiva
Diversamente da quanto prospettato dal modello comportamentista che indirizzò gran parte delle ricerche psicologiche fino agli anni ’60 e che riconosceva all’attività psichica dell’individuo la sola capacità reattiva, la Teoria Sociale Cognitiva focalizza la propria attenzione sulle determinanti sociali del comportamento e sui meccanismi cognitivi che modulano le influenze dell’ambiente (Bandura, 1962).
L’individuo, non solo reagisce agli stimoli dell’ambiente e del mondo interiore, ma agisce anche “trasformativamente” su questi in virtù di processi e strutture che integrano l’esperienza, rendono conto dell’unità, della coerenza e della continuità della personalità e dirigono la condotta secondo mete e standard personali (Caprara, Borgogni, Barbaranelli, Rubinacci, 1999).
L’individuo non è solo reattivo all’ambiente, ma ha proprietà autoriflessive che gli consentono di apprendere e generare nuove capacità e di agire proattivamente nel rapporto con il mondo che lo circonda (Bandura,1989,1999).
La mente umana è una forza attiva che costruisce la propria realtà, selettivamente codifica le informazioni, sviluppa comportamenti sulla base dei propri valori ed aspettative, ed impone una struttura alle sue stesse azioni (Jones, 1989).
L’individuo ha quindi, capacità di osservazione, valutazione, pianificazione degli obiettivi e prefigurazione delle conseguenze; ha la facoltà di confrontare le esperienze pregresse con quelle del presente ed è in grado di auto motivarsi, premiarsi e penalizzarsi (Pajares, 2002).
Di seguito verranno presi in considerazione gli aspetti più importanti sui quali si fonda la Teoria Sociale Cognitiva: a) l’agentività umana, attraverso la quale l’individuo si confronta direttamente con l’ambiente e prende coscienza degli aspetti di sé; b) il Determinismo Reciproco Triadico che evidenzia come fattori personali sotto forma di processi cognitivi, affettivi-biologici, comportamento ed influenza ambientale, diano vita ad interazioni reciproche e triadiche; c) efficacia personale e collettiva, fondamentali per comprendere come gli individui si confrontano, rispettivamente come singoli o come insieme organizzato, con i compiti e le sfide associate al perseguimento degli obiettivi organizzativi (Borgogni, 2001).
Il Determinismo Reciproco Triadico
La teoria sociale cognitiva definisce il comportamento umano come un’interazione triadica, dinamica e reciproca (Figura 1), tra fattori personali, comportamento ed ambiente (Bandura, 1977, 1986, 1989).
Figura 1 – Relazione tra le tre principali classi di determinanti nel modello del “determinismo reciproco triadico” di Bandura. P = fattori interni (cognitivi, affettivi, biologici); C = comportamento; A= ambiente esterno
Ogni fattore cognitivo, affettivo e biologico interno all’individuo avrà un’influenza sull’ambiente circostante, allo stesso modo, il luogo o la situazione, nella quale la persona si trova, ne influenzeranno i pensieri, le aspettative, gli affetti e di conseguenza il comportamento. Quest’ultimo è sia un prodotto della persona e dell’ambiente, sia un loro produttore: le azioni individuali incidono sull’ambiente modificandolo, e sulla persona che si trova a confrontarsi con le proprie azioni.
La persona è infatti portatrice di strutture conoscitivo-motivazionali che le permettono di agire selettivamente e costruttivamente sull’ambiente. La teoria sociale cognitiva, a tal proposito, distingue tre tipi di strutture ambientali: ambiente imposto, selezionato e costruito (Bandura, 1997).
Il comportamento umano è determinato, non solo dall’ambiente, ma anche dallo stesso individuo che ha la facoltà di comprendere aspetti dell’esperienza passata, trasformarli, aggiungere caratteristiche nuove e quindi creare qualcosa che non sia solo un’integrazione o una replica del passato (Bandura, 2000a).
Le condizioni ambientali, seppur mediate dalla capacità dell’individuo di assegnare significato alle sue richieste e di cogliere tutte le opportunità, hanno un ruolo determinante nel fornire la cornice e le condizioni entro cui e tramite cui, si dispiegano lo sviluppo ed il funzionamento dell’individuo (Caprara, Borgogni, Barbaranelli, Rubinacci, 1999).
L’ambiente sociale offre standard e modelli volti a favorire lo sviluppo di capacità fondamentali per il consolidamento di un’identità personale e per il mantenimento del controllo su sé e sull’ambiente (Borgogni, 2001).
Tuttavia, questa interazione reciproca non implica che tutte le fonti di influenza abbiano lo stesso potere. La teoria sociale cognitiva riconosce infatti che alcuni fattori hanno più peso di altri e non è detto che questi si verifichino simultaneamente. L’interazione dei tre fattori varierà a seconda della specificità della situazione in esame: ogni essere umano, quale unico nel suo genere per caratteristiche fisio-psichiche ed esperienze pregresse, ha reazioni diverse al proprio ambiente sociale e dà quindi vita a comportamenti diversi (Bandura, 2000a).
Human Agency
La Teoria Sociale Cognitiva affonda le sue radici in una prospettiva agentiva nella quale le persone funzionano come regolatori proattivi anticipanti, propositivi e auto-valutanti della loro motivazione e delle loro azioni. La capacità di esercitare il controllo sull’ambiente e sulla qualità della vita di ciascuno è infatti l’essenza dell’essere umano (Bandura, 2001).
L’agentività è una tipica proprietà della mente, per cui essa è in grado non solo di reagire a stimoli esterni provenienti dall’ambiente, e psico-biologici della persona, ma anche di intervenire in senso causale sulla realtà (Bandura, 2000a).
Attraverso quello che Bandura chiama “sistema del sé”, l’individuo è in grado di organizzare e massimizzare le proprie capacità e le opportunità offerte dall’ambiente al fine di raggiungere gli obiettivi e le mete prefissate. L’espressione delle proprie potenzialità in accordo alle reali possibilità messe a disposizione dalla condizione sociale, costituisce il fondamento della human agency e l’elemento distintivo di ciascuna individualità (Caprara, Borgogni, Barbaranelli, Rubinacci, 1999).
Con l’introduzione del concetto di human agency, Bandura (2000a) supera la storica dicotomia tra sé oggetto e sé agente, sostenendo l’essere agentivo dell’individuo sia quando riflette su se stesso, sia quando esercita un’influenza sull’ambiente esterno.
Nella quotidianità le persone assumono allo stesso tempo il ruolo di agenti ed oggetti nel momento in cui intervengono attivamente sull’ambiente e riflettono sulle proprie capacità e strategie d’azione.
L’human agency è stata spesso associata al concetto di agentività personale esercitata individualmente (direct personal agency). Tuttavia, l’esercizio dell’agency può assumere altre forme. In molte sfere della vita, le persone non hanno sempre un controllo diretto sulle condizioni sociali e sulle pratiche istituzionali, che quotidianamente influiscono sulle loro vite (Bandura, 2001, 2002, 2006).
La teoria sociale cognitiva a tal proposito, evidenzia altre due modalità d’azione: agentività vicaria (proxy agency) che si realizza attraverso l’azione di qualcun altro per assicurarsi i risultati desiderati, e collettiva (collettive agency), esercitata attraverso sforzi sociali interdipendenti.
Difficilmente le persone hanno il tempo, l’energia e le risorse per padroneggiare ogni campo della vita, così, una strategia di successo, presuppone necessariamente fiducia nell’azione altrui, che avvenga in modo vicario o attraverso l’azione collettiva, affinché si possa avere l’opportunità di gestire al meglio anche altri aspetti della vita (Baltes, 1996; Brandtstadter, 1992).
Nel caso della proxy agency, il benessere, la sicurezza ed i risultati di qualità si ricercano attraverso una mediazione sociale: le persone cercano di utilizzare coloro che hanno accesso alle risorse o che esercitano il potere, per raggiungere i risultati desiderati.
Coloro i quali utilizzano questa tipologia di agentività devono, infatti, poter credere che altri siano più in grado di portare a termine il compito per quelle situazioni in cui o risultano sprovvisti degli strumenti necessari o semplicemente non hanno il desiderio di affrontare sforzi che invece il controllo diretto implica (Bandura, 2001). Infine la teoria sociale cognitiva ha esteso il concetto di human agency, anche all’azione collettiva (Bandura, 1997). Alla base della collettive agency vi è la fiducia delle persone nella loro capacità di produrre risultati congiunti: il successo di un gruppo è il prodotto non solo delle intenzioni condivise, delle capacità e conoscenze dei suoi membri, ma anche la risultante delle dinamiche sinergiche, coordinante ed interattive delle loro transizioni (Bandura, 2001).
Le fondamentali capacità umane
Attraverso fondamentali capacità, l’individuo è in grado di ridurre i condizionamenti interni del proprio organismo ed esterni del proprio ambiente e di espandere le occasioni del proprio sviluppo (Borgogni, 2001). Tali capacità indicative della proattività della mente e quindi appartenenti alla natura stessa dell’essere umano (Bandura, 2001), possono così essere identificate:
1. Capacità di simbolizzazione attraverso la quale le esperienze vengono dotate di significato, immagazzinate nella memoria e continuamente rielaborate sotto forma di giudizi volti a guidare l’azione in accordo ai principi di coerenza e continuità. Grazie a tale capacità le persone possono testare ipotesi alternative e risolvere problemi senza dover necessariamente passare all’azione (Borgogni, 2001).
2. Capacità vicarie di apprendimento per imitazione che permettono di aumentare il proprio bagaglio di competenze, e quindi di comportamenti possibili, senza dover sperimentare sulla propria persona alcun tipo di azione, ma osservando quelle altrui (Bandura, 1986). L’apprendimento per imitazione segue quattro step. Inizialmente un processo di attenzione determina dove focalizzare la propria attenzione e quali informazioni selezionare. In seguito processi rappresentazionali e di memoria trasformano i concetti in modo da poterli immagazzinare, ricordare e tradurre in specifiche azioni in seguito messe in pratica nel processo di produzione comportamentale, e sostenute da agenti motivazionali fondamentali alla persona per le loro capacità incentivanti che le permettono di portare a termine l’azione intrapresa (Borgogni, 2001).
3. Capacità di anticipazione mediante la quale la persona si proietta nel futuro ed in base a ciò che prefigura, calibra la sua condotta. Grazie a questa capacità gli individui selezionano obiettivi anticipando i possibili effetti delle proprie azioni e, di conseguenza, creano situazioni che possano verosimilmente produrre i risultati desiderati ed impedire quelli indesiderati (Bandura, 1990; Feather, 1982; Locke, Lathan, 1990). Nella quotidianità, infatti, le persone pianificano rispetto al futuro, riordinano le loro priorità e strutturano le loro vite di conseguenza (Bandura, 2001). Una previsione riguardante questioni importanti di non immediata realizzazione, fornisce all’individuo la direzione, la coerenza ed il punto di riferimento di tutto il corso delle sue azioni. Gli eventi futuri, tuttavia, non possono, naturalmente, essere causa di costante motivazione o azione, poiché non si sono ancora verificati. Così grazie al supporto cognitivo che permette di prefigurarli, i prevedibili eventi futuri vengono convertiti in motivazioni del presente e quindi regolatori del comportamento (Bandura, 2001, 2006). In questa forma di “auto-guida anticipatoria” (Bandura, 2001, p.7), il comportamento è motivato e diretto dagli obiettivi stabiliti e dai risultati anticipati, piuttosto che essere motivato solo da un futuro non ancora realizzato.
4. Capacità di autoregolazione grazie alla quale la persona orienta e motiva se stessa in accordo con obiettivi e standard personali. L’azione coinvolge quindi, non solo la capacità di fare delle scelte e decidere piani d’azione, ma anche la possibilità di dare forma ad interventi appropriati, motivando e regolando la loro esecuzione (Bandura, 2001, 2006). Ciò comporta l’interiorizzazione di sanzioni e richieste che provengono dall’esterno in un sistema interno di regolazione e direzione del sé. Una volta che tale sistema è consolidato, le richieste e le sanzioni personali, già precedentemente interiorizzate, divengono motivatori guida della condotta (Borgogni, 2001). In particolare tale auto-regolazione di motivazioni, effetti ed azioni, opera attraverso sotto-funzioni autoreferenziali quali: l’auto-osservazione (self-observation) che permette di prestare attenzione ai processi di pensiero ed alla prestazione effettivamente realizzata, l’auto-reazione (self-reaction) importante affinché la persona possa dare vita ad azioni positive o negative e l’auto-valutazione (judmental process) che giudica tali azioni attraverso standard personali (Bandura, 1986, 1990).
5. Capacità di autoriflessione mediante la quale le persone analizzano le proprie esperienze, ragionano sui propri processi di pensiero e di azione (Borgogni, 2001). Le persone non sono, quindi, solo agenti di azioni, ma anche auto-esaminatori del loro stesso funzionamento. Attraverso un’auto consapevolezza possono riflettere sulla loro efficacia personale, sull’esattezza dei loro pensieri ed azioni, sul significato dei loro propositi ed effettuare correzioni, qualora siano necessarie (Bandura, 2006). Il funzionamento di tale capacità dipende da un’attività meta-cognitiva ad essa connessa che consente di distinguere tra pensieri incongrui o corretti. A tal proposito Bandura propone quattro modalità di verifica del pensiero che si esplicano mediante: un’analisi attiva (enactive), in cui le persone sondano direttamente la veridicità del loro giudizio tramite la bontà dei loro stessi ragionamenti; logica, si affidano a modelli teorici già noti ed accettati; vicaria, basano la loro riflessione sull’osservazione degli effetti del comportamento altrui; ed infine persuasoria nei casi in cui non sia possibile una verifica diretta della veridicità del pensiero si affidano al giudizio di persone ritenute attendibili e competenti (Borgogni, 2001).
L’efficacia personale
Le diverse aree delle attività umane richiedono agli individui di possedere molteplici conoscenze ed abilità. È evidente però che una singola persona non possa ottenere una piena padronanza in tutti gli ambiti, poiché questo comporterebbe un’enorme quantità di tempo, risorse ed impegno. Ogni individuo ha quindi la possibilità di differenziarsi sia per la scelta delle aree in cui investire energie e capacità, sia per i livelli di efficacia posseduti nelle varie attività intraprese (Bandura, 2000a).
A tal proposito Bandura (1986), sottolinea come i modelli specifici di competenze sviluppati dagli individui e prodotti dalle esperienze socioculturali, circostanze fortuite e doti naturali, siano le principali cause dei cambiamenti nell’andamento delle traiettorie evolutive personali.
La Teoria Sociale Cognitiva riconosce, inoltre, l’eterogeneità delle capacità umane e considera, per questo motivo, il sistema delle convinzioni di efficacia non come un tratto generale, ma come un insieme differenziato di convinzioni possedute dall’individuo su di sé e sulle diverse sfere in cui si esplica la sua attività (Bandura, 2000a).
Bandura (1986), introdusse a tal proposito, il concetto di autoefficacia definendola come la convinzione di possedere specifiche capacità per poter organizzare ed eseguire sequenze d’azioni necessarie a produrre i risultati attesi.
L’autoefficacia percepita, benché sia stata spesso assimilata a costrutti come l’autostima, il concetto di sé, il locus of control e la competenza, non corrisponde ad un’ipotetica disposizione o ad un generale senso di controllo o competenza (Bandura, 1986). Sebbene siano tutte espressioni del medesimo sistema che regola i rapporti della persona con la realtà, le varie convinzioni di efficacia sono pertinenti a specifiche sfere di attività e riflettono processi affettivi-cognitivi che selezionano gli interventi da realizzare per ottenere i risultati attesi (Caprara, Borgogni, Barbaranelli, Rubinacci,1999).
È inoltre importante sottolineare come l’autoefficacia non sia relativa a percezioni momentanee di competenze, ma a stime più resistenti e durature. Le persone infatti regolarmente sovrastimano o sottostimano le loro attuali capacità, e queste valutazioni erronee possono poi avere conseguenze sul corso dell’azione che hanno scelto di affrontare, sulla scelta degli obiettivi e sugli sforzi che intendono impiegare (Goddard, Hoy, Woolfolk Hoy, 2004).
A tal proposito, Bandura (1997) sottolinea, come l’auto valutazione determini il modo in cui le persone faranno un buono o cattivo utilizzo delle proprie capacità di fronte a compiti difficili.
Le convinzioni di autoefficacia regolano inoltre il funzionamento umano tramite processi cognitivi, motivazionali, decisionali ed emotivi (Bandura, 1997). Esse influiscono sugli individui e sul loro modo di pensare in termini di auto-rafforzamento o auto-debilitazione, su quanto bene si motivano a perseverare di fronte alle difficoltà, sulla qualità del loro benessere emotivo e sulla loro vulnerabilità allo stress ed alla depressione e sulle scelte che operano di fronte a decisioni importanti (Bandura, Locke, 2003).
Le fonti dell’autoefficacia
Buona parte della ricerca che ha analizzato l’applicazione del modello di autoefficacia nello sport e nell’attività fisica si è orientata alla comprensione degli effetti dei quattro antecedenti, indicati da Bandura, (esecuzione dell’azione, esperienze vicarie, persuasione verbale e stato fisiologico) sulla percezione di efficacia dello sport e nelle situazioni competitive (Cei, 1998):
1. Messa alla prova diretta (mastery experience) – L’esperienza diretta del successo rappresenta la fonte più influente nella generazione del senso di autoefficacia. I fallimenti, al contrario, sono altamente debilitanti, soprattutto se avvengono prima che la convinzione sia consolidata. Tuttavia, se gli atleti sperimentassero solo facili successi, finirebbero per aspettarsi di ottenere sempre risultati veloci e di conseguenza si lascerebbero maggiormente scoraggiare dall’insuccesso. Ostacoli e difficoltà permettono, infatti, agli individui di comprendere come il successo di una prestazione dipenda dagli sforzi profusi e dalle risorse investite. Per questo motivo, affinché le proprie convinzioni di autoefficacia siano sviluppate, è necessario che gli atleti si mettano alla prova in compiti di difficoltà gradualmente crescenti, effettuando verifiche continue sulle proprie capacità e facendo tesoro dell’esperienza precedente fondamentale per orientare le azioni future (Bandura, 1997, 2000a). In particolare, la ricerca condotta in ambito sportivo ha dimostrato che l’esecuzione della prestazione migliora la percezione di autoefficacia e che le informazioni che l’atleta trae dalla valutazione delle sue prestazioni sono molto importanti per l’affermarsi di una condizione psicologica di fiducia nelle proprie capacità (Brody, Hartfield & Spalding 1988; McAuley 1985).
2. Osservazione dell’operato degli altri (vicarious experiences) – L’esperienza vicaria, associata all’osservazione di modelli di successo, è una fonte meno incisiva rispetto alle esperienze dirette, ma comunque importante in quanto incoraggia gli atleti ad intraprendere un’azione suggerendo le probabili soluzioni per raggiungere l’obiettivo. L’osservazione di modelli sviluppa e rafforza l’autoefficacia mediante l’acquisizione di strategie d’azione e di informazioni rilevanti per affrontare il compito. Essa è tanto più influente quanto più il modello è simile e vicino a se stessi e quanto più le operazioni che portano al risultato desiderato sono chiare nella loro sequenza ed articolazione. Tuttavia, in alcune situazioni le informazioni tratte dall’osservazione di prestazioni altrui, possono avere effetti differenti. Un’atleta che osserva sportivi a lui simili raggiungere prestazioni di successo con le proprie forze, potrà arrivare a credere di possedere le stesse capacità e probabilità di raggiungere il medesimo risultato. Se invece l’osservazione si focalizza su un’atleta che, pur essendo competente, fallisce nella sua prestazione a causa di strategie inadeguate, le percezioni di efficacia dello spettatore aumenteranno poiché questo sarà portato a credere di avere a disposizione strategie più idonee. Al contrario, vedere un’agonista capace che riesce a malapena ad ottenere risultati, nonostante l’impiego delle tattiche migliori, può indurre l’osservatore a giudicare il compito molto più difficile di quanto non pensasse in precedenza (Bandura, 1997, 2000). Nello sport è facile che si verifichino tutti questi esempi, poiché viene spesso richiesto agli atleti di osservare compagni più esperti o atleti di livello superiore per comprendere e migliorare le proprie prestazioni individuali. Tale approccio si è dimostrato valido, ad esempio, in compiti di resistenza muscolare (George, Feltz & Chase, 1992), nella ginnastica (McAuley, 1985) ed in compiti di equilibrio (Feltz, Lirgg, 1991). Alcune indagini si sono servite dell’effetto che produce la comparazione tra la prestazione individuale e quella di un modello sull’efficacia dei soggetti esaminati. In particolare, George e colleghi hanno richiesto a delle studentesse del college di seguire un video in cui un’atleta portava avanti una prova di resistenza, estendendo una gamba, e valutare attraverso un questionario la loro percezione di efficacia ed in seguito di provare ad eseguire l’esercizio. I modelli osservati erano quattro: due atleti, un maschio ed una femmina, ed un maschio ed una femmina non-atleti. Dallo studio è emerso che un modello dello stesso sesso dell’osservatore che manifesta un buon livello di competenza, stimolerà in modo maggiore la fiducia in sé dell’osservatore e la sua conseguente prestazione di resistenza. Inoltre, Lirgg e Feltz hanno riscontrato che gli osservatori riducevano in modo significativo la loro convinzione di efficacia quando guardavano un modello che, anche se era stato presentato come competente, agiva in modo poco abile, rispetto a coloro che osservavano un modello che forniva una prestazione in modo competente.
3. Venire persuasi da altri di essere all’altezza delle situazioni (social persuasion) – L’essere persuasi da altri di possedere le abilità necessarie al raggiungimento di specifici obiettivi o per il superamento di determinate difficoltà, influisce sulla percezione della propria autoefficacia in misura proporzionale alla credibilità della fonte di persuasione. Se un individuo viene persuaso di poter raggiungere l’obiettivo prefissato intensificherà lo sforzo e sarà maggiormente perseverante rispetto a quelli che non ricevono lo stesso incoraggiamento quando incontrano difficoltà (Bandura, 1997, 2000). L’effetto maggiore si ha quando ha già qualche motivo per credere di poter produrre gli effetti con le proprie azioni (Chambliss, Murray, 1979a; 1979b). Qualora, invece, si alimenta un senso di capacità irrealistico, si aumenterà solo la probabilità di insuccessi e conseguentemente diminuirà la percezione dell’efficacia personale di chi si è fatto persuadere. Le informazioni persuasorie vengono spesso trasmesse attraverso feedback. Schunk e colleghi (1986) analizzarono gli effetti di tali valutazioni sulle convinzioni di efficacia personale. Nella loro ricerca presero in esame alcuni alunni che, per colmare carenze nelle materie scientifiche e letterarie, dovevano seguire un programma di istruzione autodiretta. Durante tale progetto ricevevano costantemente feedback prestabiliti e quindi indipendenti dalle loro reali prestazioni. Da tale studio è emerso che la presenza di feedback relativi alle capacità personali accresce le convinzioni di efficacia personale soprattutto nei casi in cui tali valutazioni attestano che l’individuo è in possesso delle capacità necessarie per portare a termine con successo l’attività in questione. L’attribuire, invece, il miglioramento delle capacità all’impegno profuso nella performance può sostenere la motivazione dell’individuo solo nel breve periodo. Al contrario se tale feedback persiste, va ad influire negativamente sulla percezione dell’autoefficacia dei persuasi, poiché questi possono arrivare a pensare di possedere ridotte capacità se necessitano sempre di lavorare duro per ottenere i risultati desiderati. Uno dei più comuni effetti di persuasione verbale è quello fornito dall’allenatore, che attraverso la conoscenza dell’atleta può alterare le informazioni ed i feedback che fornisce sia in allenamento che in gara. Fitzsimmons e colleghi (1991) hanno studiato la percezione di autoefficacia in atleti esperti per verificare se feedback falsi potevano influenzare la loro prestazione. Gli atleti, pesisti, sono stati divisi in modo casuale in tre gruppi diversi per quanto riguarda i feedback che ricevevano sulla loro prestazione: corretta informazione sulla prestazione, falso feedback positivo (prestazione superiore a quella realmente fornita) e falso feedback negativo (prestazione inferiore a quella realmente fornita). Dai risultati è emerso che, sebbene la manipolazione in termini positivi del feedback determinava un incremento della prestazione successiva, questo miglioramento era in realtà molto limitato in quanto, trattandosi di atleti già ad un buon livello di preparazione, tra una prova e l’altra non potevano avvenire cambiamenti rilevanti. Benché i risultati emersi in più ricerche, testimonino la ridotta efficacia della persuasione verbale, le convinzioni degli insegnanti e degli allenatori sulla loro capacità di persuasione verbale rimangono comunque forti e radicate. Infatti, da un’indagine condotta da Weinberg e Jackson (1990) su allenatori di tennis, è emerso che essi attribuiscono notevole importanza al dialogo interno positivo ed alla persuasione verbale come strategie per incrementare la percezione di efficacia. Appare evidente che questi allenatori non fossero consapevoli che le esperienze dei loro allievi neutralizzavano questo tipo di approccio, e che invece il principale modo per favorire lo sviluppo di sentimenti di autoefficacia risiedeva nel favorire il raggiungimento di prestazioni positive come testimoniato da precedenti ricerche di Feltz e Riessinger (1990). A tal proposito, è emerso che le manipolazioni dovute al trattamento hanno solo un effetto a breve termine, che scopare immediatamente dopo un insuccesso e che la percezione che i soggetti hanno delle loro prestazione non deve essere influenzata negativamente dal trattamento sperimentale, in quanto costituisce la principale fonte informativa individuale.
4. Controllo della tensione interna e delle emozioni (physical and emotional states) – Le persone si affidano ai propri stati emotivi e fisici per giudicare le proprie capacità. Interpretano stati di tensione, ansia e depressione come segnali di difficoltà personali. Poiché una sensazione eccessiva di attivazione può peggiorare la prestazione, tendenzialmente le persone prevedono di poter eseguire prestazioni migliori quando non sono tese e non percepiscono il sentore dell’agitazione. Nelle situazioni che implicano forza e resistenza tenderanno invece ad interpretare la fatica come un indicatore di inefficacia fisica. Per favorire lo sviluppo e rafforzamento dell’autoefficacia sono quindi necessarie strategie di monitorizzazione ed autoregolazione che possano contribuire ad aumentare il benessere psicofisico e ridurre le percezioni negative (Bandura, 1997, 2000a).
Tali esperienze non sono di per sé indici oggettivi dell’efficacia personale, ma influiranno sul senso di autoefficacia solo dopo essere state elaborate cognitivamente (Bandura, 2000a). Le informazioni che ciascuno trae dall’esperienza assumono infatti valore informativo in relazione a come vengono selezionate, pesate, valutate ed integrate in giudizi di efficacia (Borgogni, 2001).
Autoefficacia e prestazione sportiva
Anche nello sport l’autoefficacia è definita come la “fiducia che una persona ripone nella propria capacità di affrontare un compito specifico” (Bandura, 1986).
Il significato di autoefficacia dell’atleta è esprimibile con la capacità d’influire, in maniera quanto più possibile determinante, ovviamente in positivo, sull’evento sportivo o su aspetti ad esso strettamente collegati: coesione di squadra, elaborazione di tattiche di gioco.
Diversi studi sono stati condotti al fine di verificare gli effetti delle convinzioni di efficacia. Tali ricerche hanno interessato prestazioni connesse all’attività lavorativa, sia in laboratorio che sul campo (Sadri, Robertson, 1993; Stajkovic, Luthans, 1998), il funzionamento psico-sociale nei bambini e negli adolescenti (Holden, Moncher, Schinke, Barker, 1990), il rendimento accademico (Multon, Brown, Lent, 1991), le prestazioni atletiche (Moritz, Feltz, Fahrbach, Mack, 2000) e la percezione dell’efficacia nel funzionamento dei gruppi (Gully, Incalcaterra, Joshi, Beaubien, 2002; Stajkovic, Lee, 2001).
Tutte queste meta-analisi, condotte con una vasta gamma di approcci differenti , hanno confermato lo stretto legame tra efficacia percepita e prestazione indicando nelle convinzioni di autoefficacia i predittori più affidabili del successo dell’attività. Nello specifico, le convinzioni di autoefficacia non solo predicono le dinamiche comportamentali che verranno messe in atto dagli individui a differenti livelli di percezione di efficacia personale, ma anche il modo con cui queste dinamiche cambieranno nel tempo e persino le variazioni che si verificheranno nello stesso individuo rispetto ai compiti svolti ed a quelli evitati o falliti.
L’efficacia percepita e la prestazione si influenzano a vicenda e sono suscettibili di attivare delle spirali di miglioramento (o peggioramento) reciproche, ovvero sequenze di miglioramenti a catena di efficacia che agisce sulla prestazione e ne migliora gli esiti, che a loro volta potenziano le convinzioni di efficacia della persona e la spingono verso standard più elevati (Lindsley, Brass, Thomas, 1995).
I ricercatori si trovano d’accordo nel ritenere che persone con un alto senso di autoefficacia percepiscono le difficoltà come occasioni per mettersi alla prova, hanno alti livelli di aspirazione, si impegnano a fondo, non si soffermano troppo su ripensamenti e si focalizzano sulla soluzione dei problemi cercando infine di rimediare o compensare, piuttosto che giustificare, le proprie insufficienze (Borgogni, 2001).
Persone con alta autoefficacia sono inoltre in grado di selezionare situazioni più impegnative e stimolanti fornendo contributi innovativi e creativi alla risoluzione dei compiti (Schwarzer, Schmitz, 2004).
In mancanza di un livello minimo di autoefficacia, le persone dovrebbero rinunciare a portare a termine i loro obiettivi, anche se in possesso delle abilità necessarie per eseguire almeno parte dell’azione (Lucas, Cooper, 2005).
Naturalmente un’elevata percezione di autoefficacia non è garanzia di riuscita in situazioni che presentano ostacoli e difficoltà, ma sicuramente orienta le persone a cimentarsi nelle avversità ed a mobilitare le proprie risorse per risolvere gli eventuali problemi (Borgogni, Petitta, 2003).
Problemi ed incertezze, sono inevitabili ingredienti del percorso per il raggiungimento di una meta. Una delle principali funzioni del pensiero è quella di rendere le persone in grado di prevedere gli eventi e di sviluppare modalità specifiche per controllare le situazioni che interessano la loro vita. Le persone con elevata autoefficacia mostrano infatti maggiori risorse cognitive (Wood, Atkins, Tabernero, 2000).
Altri studi hanno esaminato in che modo ulteriori aspetti connessi all’esercizio fisico (impegno e resistenza) sono influenzati dall’autoefficacia. I risultati hanno evidenziato che il raggiungimento degli obiettivi stimola positivamente il senso di autoefficacia e si evidenzia una stretta relazione fra goal setting e autoefficacia stessa: le persone hanno la necessità di porsi delle mete che possono raggiungere attraverso il loro impegno e i loro sforzi (Bandura e Cervone, 1983).
Una persona che dubita della propria efficacia incontrando delle difficoltà, degli ostacoli o sperimentando un fallimento, rallenta lo sforzo, abbandona il compito o si accontenta di soluzioni mediocri. Un individuo con elevata autoefficacia, invece, tende a aumentare lo sforzo, si rappresenta modi migliori per affrontare le sfide, si assegna obiettivi stimolanti, si aspetta che i suoi sforzi producano risultati favorevoli, attribuisce i fallimenti a fattori che sono potenzialmente controllabili con lo sforzo e l’astuzia, vede gli ostacoli come superabili ed immagina come fronteggiarli (Borgogni, Petitta, 2003).
McAuley (1985) ha esaminato che, nella relazione tra autoefficacia e ansia, in una determinata attività sportiva, quest’ultima tende a ridursi in funzione dell’aumento della percezione delle proprie competenze che gli atleti acquisiscono tramite condizioni di modellamento.
Un’ulteriore ricerca ha evidenziato che la partecipazione ad un programma di sviluppo della forza muscolare migliora non solo la percezione di efficacia in relazione ad un compito specifico connesso con questa attività, ma anche l’autoefficacia in diverse aree come l’autostima e l’abilità a confronti di opposizione (Holloway, Beuter e Duda, 1988).
Ancora McAuley (1992) ha preso in considerazione l’autoefficacia e l’attività fisica in una relazione circolare dove la prima rappresenta il fattore che favorisce l’adesione e la persistenza a condurre una vita fisicamente attiva, mentre l’attività fisica promuove, di conseguenza, un sentimento di efficacia personale.
Secondo tale modello l’autoefficacia è generata da un processo psicofisiologico circolare che permette all’individuo di leggere per sintesi afferente (informazioni provenienti dalla periferia del corpo) le percezioni e le sensazioni corporee che caratterizzano lo stato psicofisico dell’attivazione preparatoria ad un comportamento o ad una gara (un’atleta poco prima della gara). Queste informazioni vengono integrate con l’esperienza passata (comportamenti simili già messi in atto in passato), con le persuasioni verbali (positive o negative) provenienti dall’ambiente (un allenatore ad esempio) e con le esperienze vicarie (vedere un altro atleta che riesce nel compito), ed elaborate cognitivamente dando origine ad un vissuto emotivo, soggettivo, che orienterà le scelte comportamentali. Il risultato di tali scelte e del comportamento messo in atto, influenzerà in maniera retroattiva la percezione di autoefficacia e la memoria.
Le convinzioni di autoefficacia, inoltre, favoriscono un’appropriata gestione degli stressor da competizione: gli atleti che mostrano più radicate convinzioni hanno maggiori capacità di concentrarsi sulle tecniche più appropriate per superare i propri limiti, affrontando al meglio le difficoltà, lo stress ed i rischi connessi alla continua competizione. Essi mostrano, anche, una maggiore abilità nello gestire le distrazioni ed i pensieri negativi relativi ad insuccessi passati e nel controllare adeguatamente l’ansia solitamente precedente la competizione. Al contrario gli atleti che dubitano delle proprie potenzialità saranno più inclini a sopravvalutare le doti atletiche degli avversari ed a preoccuparsi esageratamente dei rischi e delle conseguenze negative del fallimento. Tendono, inoltre, a rimuginare a lungo sui propri errori e ad anticipare futuri scenari di insuccesso. Solide convinzioni di autoefficacia permettono di partecipare in modo propositivo a lunghi programmi di riabilitazione dopo infortuni e favoriscono la scelta di obiettivi a breve e lungo termine adeguati alle effettive possibilità di recupero (Steca, 2011).
Con gli odierni programmi di preparazione l’allenatore può intervenire sull’autoefficacia favorendo il consolidamento delle aspettative future attraverso la programmazione di sedute di allenamento finalizzate al superamento degli ostacoli. Questo vuol dire che il tecnico deve necessariamente conoscere le abilità dei propri atleti e con questa conoscenza costruire un programma di preparazione che si basi su fini ed obiettivi concreti, reali e rispettosi delle capacità dei singoli e della squadra. Deve, dunque, prefissare la meta da raggiungere e la quantità di sforzo necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo. Deve, inoltre, considerare la frustrazione derivante dal fallimento come un momento di riverifica degli obiettivi concordati.
Se l’allenatore dovesse rendersi conto che l’atleta ha scelto una meta superiore alle proprie capacità, dovrebbe riuscire, senza dimostrare scarsa stima nelle qualità tecniche o fisiche dell’allievo, a far si che questo sposti l’obiettivo ad una portata più realistica.
Una volta individuata la meta da raggiungere, l’atleta procederà verso di essa sviluppando o meno la convinzione nelle proprie capacità di poter pianificare e realizzare azioni e comportamenti atti a realizzare le proprie aspirazioni. Tenere d’occhio le manifestazioni di tensione e stress che vengono dagli atleti, passare del tempo con loro, parlare di argomenti vari, può essere un buon modo per aprire un canale preferenziale alla comunicazione e procurarsi una chiave di lettura a determinati comportamenti che possono rappresentare un campanello d’allarme che non deve essere sottovalutato.
Diventa fondamentale, quindi, che gli allenatori siano in grado d’insegnare all’atleta ad essere consapevole dei propri vissuti psicofisiologici e qui entra in gioco lo psicologo che deve fornire all’allenatore gli strumenti e soprattutto la preparazione personale per poter intervenire in modo adeguato nei confronti dell’atleta.
Efficacia collettiva
Le persone non vivono in condizioni di isolamento sociale, né potrebbero controllare autonomamente gli aspetti più importanti della loro vita. Molte sfide quotidiane riguardano infatti problemi comuni che, per essere risolti, richiedono il contributo interdipendente di più persone (Bandura, 2000a).
In molti setting sportivi, così come in ambito economico, militare e organizzativo le persone necessitano di lavorare insieme unendo le loro risorse per raggiungere obiettivi comuni (Mayers, Payment, Feltz, 2004).
Esistono però gruppi composti da persone estremamente dotate e competenti individualmente, ma che non raggiungono i risultati prefissati. La spiegazione di tale fenomeno, risiede nel fatto che non bastano le conoscenze e le abilità possedute da ciascuno, ma sono necessari continui scambi interattivi e sinergici tra i componenti del un team (Bandura, 1990).
La capacità del gruppo di coordinarsi ed agire sinergicamente deriva dalla condivisione di credenze circa le proprie competenze operative (Borgogni, 2001). Bandura (1997) introduce a tal proposito, il concetto di efficacia collettiva definita come la convinzione condivisa che il gruppo del quale si fa parte sia capace di organizzare ed eseguire le azioni necessarie per produrre determinati risultati.
L’efficacia collettiva va ad influenzare direttamente le scelte delle persone all’interno del gruppo, la qualità delle risorse investite negli obiettivi comuni e la persistenza nell’attività anche di fronte a fallimenti ed insuccessi (Bandura, 2000a).
Così come sottolinea Gibson (2003) l’efficacia collettiva riflette, non solo le credenze condivise della squadra circa le proprie capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati, ma anche le convinzioni sulle loro capacità di mobilizzare la motivazione, le risorse cognitive ed i corsi d’azione necessari a produrre livelli di risultati in uno specifico compito.
Zaccaro et al (1995), incorporano nella definizione di Bandura dell’efficacia collettiva, anche gli aspetti integrativi e coordinativi di tale costrutto, definendola come “un senso di competenza collettiva diffuso tra i membri di un gruppo nel momento in cui devono assegnare, coordinare ed integrare le loro risorse per ottenere una prestazione di successo e condivisa in una specifica situazione” (pag. 309).
Bandura (2000a) suggerisce inoltre, due criteri per determinare la stima delle percezioni dell’efficacia collettiva. Il primo consiste nell’aggregare le valutazioni dei singoli membri riguardanti la loro capacità di portare a termine uno specifico compito relativo al ruolo occupato all’interno del gruppo (stima dell’efficacia collettiva come aggregazione di auto efficace). Il secondo consiste nell’aggregare le stime delle valutazioni riguardanti la capacità del proprio gruppo di operare come un’unica entità (stima dell’efficacia collettiva come aggregazione di efficace collettive). Quest’ultimo giudizio, essendo di carattere olistico, rende ragione di una serie di dinamiche attive all’interno dei gruppi quali: i processi di interazione, coordinamento e collaborazione.
Ciò che orienta la scelta tra un approccio e l’altro è il livello di interdipendenza previsto in determinati compiti che i membri di un gruppo si trovano ad affrontare. In una squadra di ginnasti, la stima dell’efficacia collettiva sarà data dall’aggregazione delle efficace personali e la prestazione sarà valutata sulla base della performance prodotta in modo indipendente dai singoli atleti (Bandura, 2000a, Caprara, 2000).
In squadre di football o hockey, ad elevata interdipendenza, il valore dell’azione personale si attenua ed il risultato della prestazione dipenderà, invece, dalla collaborazione di tutti i membri del team. In questo caso, la stima dell’efficacia collettiva coinciderà con la somma delle percezioni di efficace collettive (Bandura, 2000a).
Naturalmente, la condivisione delle percezioni di efficacia collettiva all’interno di un gruppo non implica che tutti i membri abbiano esattamente la stessa opinione su tutti gli aspetti del funzionamento del gruppo. È probabile invece, che le differenze individuali sul piano delle competenze, degli interessi, dei ruoli e dello status, diano vita a stime differenti. In particolare, individui che occupano posizioni diverse o svolgono funzioni differenti all’interno dello stesso team possono dare giudizi discordanti in merito alla loro percezione dell’efficacia collettiva (Bandura, 1993).
È vero anche che le divergenze sulle convinzioni di efficacia collettiva all’interno di un gruppo, dovrebbero essere minori rispetto a quelle di gruppi distinti. Qualora invece tale condizione non si verifica, il gruppo difficilmente potrà essere considerato un’unità, in quanto carente di senso di efficacia collettiva (Bandura, 2000a).
Antecedenti dell’efficacia collettiva
Negli ultimi anni numerose ricerche sono state condotte al fine di indagare quali siano i fattori che concorrono a generare le percezioni di efficacia collettiva ed i diversi ambiti di attività in cui queste si esplicano.
Tra gli antecedenti, un primo fattore di grande rilievo è sicuramente l’autoefficacia. Persone con bassa efficacia personale difficilmente valutano il proprio gruppo come molto efficace (Caprara, 2000) in quanto la stima delle capacità del gruppo comprende anche la propria.
In accordo con questa tesi Goddard e Goddard (2001), nei loro studi nel contesto accademico, arrivano alla conclusione che l’efficacia collettiva sia più fortemente predetta dai cambiamenti nell’efficacia personale degli insegnanti, che da altri fattori ambientali quali lo status socioeconomico degli studenti.
Ancora, Fernandez, Ballestreros, Diez, Nicolas, Caprara, Barbaranelli, Bandura (2002), sottolineano che le percezioni di efficacia individuale hanno una notevole influenza sulla percezione condivisa dei membri di un gruppo di avere la capacità di produrre un cambiamento sociale attraverso un’azione unificata.
Quando invece, ad elevate convinzioni di efficacia personale si associano basse convinzioni di efficacia collettiva, sorgono i presupposti per un aumento di demotivazione, disimpegno e conflittualità che probabilmente potranno aggravare o accelerare il declino del gruppo (Caprara, Borgogni, Barbaranelli, Rubinacci, 1999).
Sebbene, l’autoefficacia e l’efficacia collettiva siano ben distinte concettualmente, la ricerca ha dimostrato come esse siano tuttavia correlate, in quanto anche chi lavora in maniera autonoma non è mai socialmente isolato ed immune dalle influenze altrui (Bandura, 2000b).
Zaccaro et al.(1995), a tal proposito evidenziarono la similarità di alcune delle loro fonti generatrici:
– la qualità delle esperienze precedenti (dirette o vicariamente sperimentate come gruppo)
– la natura dei processi e delle influenze sociali che operano entro il gruppo.
In particolare le esperienze di successo precedenti divengono importanti predittori dell’efficacia collettiva e della prestazione attuale, soprattutto in situazioni in cui il gruppo viene esposto ad un numero elevato di esperienze positive coerenti tra loro (Spink, 1990).
Secondo Weldon e Weingart (1993) le percezione di efficacia collettiva possono anche essere influenzate da caratteristiche ambientali come le effettive capacità dei membri del gruppo (Howell, Frost, 1989), lo stile di leadership esercitata (Bass, 1985; Yukl, 1989) e la dimensione del gruppo che qualora fosse eccessiva può anche portare a fenomeni di social loafing (Zaccaro, Blair, Peterson, Zazanis, 1995), la percezione che alcuni individui si impegnino meno quando sono in gruppo rispetto a quando lavorano da soli.
Secondo questi autori, lo stile di leadership è un tassello fondamentale per la creazione e la persistenza di un’efficacia collettiva stabile. Attraverso la persuasione verbale il leader può infondere sicurezza ai suoi subordinati sulle loro capacità di essere una squadra efficace e coordinata.
Così, come nella leggenda del mitico Pigmalione che scolpendo una bellissima statua di donna, fu in grado di infonderle la vita semplicemente credendo che ciò sarebbe potuto avvenire, allo stesso modo molti dirigenti possono favorire l’efficacia collettiva dei propri dipendenti credendo nelle loro potenzialità.
“L’effetto Pigmalione” permette infatti di trasferire le aspettative del leader sui membri del gruppo sulla base del presupposto che il solo credere in un potenziale, crea potenzialità (Rosenthal, Jacobson, 1968). È stato dimostrato che tale effetto, riscontrato ad esempio nelle scolaresche e negli ambienti militari (Eden, Shani, 1982; Rosenthal, Jacobson, 1968), può portare ad un migliore rendimento del gruppo con conseguente aumento della fiducia di questo nella propria efficacia collettiva (Pescosolido, 2001).
Altri autori, (Hoyt, Halverson, Murphy, Watson, 2003), evidenziano come tanto più i leader credono che il proprio gruppo sia in grado di portare a termine i compiti richiesti, più i singoli sono pervasi dalla stessa convinzione e si adoperano in tal senso, come se i dirigenti avessero comunicato questa loro sensazione ed il gruppo l’avesse fatta propria.
Il leader è inoltre in grado di contribuire direttamente allo sviluppo delle credenze di efficacia collettiva del gruppo, agendo sul suo funzionamento con un programma di assegnazione di obiettivi comuni e di feedback fondamentali, perchè depositari di informazioni importanti per la calibrazione delle loro future prestazioni e per la scelta di strategie più adeguate ai compiti richiesti (Borgogni, 2001).
Appare infatti evidente che la percezione dell’efficacia collettiva sia anche notevolmente correlata a variabili connesse con la natura del compito e del contesto. In particolare, Gibson (1995) distingue quattro fonti: caratteristiche dei membri del gruppo, caratteristiche del gruppo, caratteristiche del compito e caratteristiche del contesto.
Allo scopo di approfondire il ruolo di tali fattori nella relazione tra efficacia percepita e prestazione lavorativa, nei precedenti vent’anni, Stajkovic e Luthans (1998) hanno condotto una meta-analisi sulla maggior parte degli studi riguardanti tale argomento, prestando particolare attenzione alla complessità del compito e dell’ambiente. La ricerca ha evidenziato che effettivamente tali variabili svolgono un importante funzione di mediazione tra le convinzioni di efficacia e le prestazioni. In particolare, l’autoefficacia risulta essere un buon predittore della prestazione a qualunque livello di complessità del compito in contesti sia reali che simulati. Tuttavia, in ambiti ad elevato grado di interdipendenza, solo in parte le convinzioni di efficacia personale possono rendere conto di risultati che dipendono maggiormente dalla collaborazione sinergica di più persone. In questi casi, come dimostrato dalla ricerca di Stajkovic e Lee (2001), dovrà essere presa in considerazione la correlazione tra l’efficacia collettiva e le prestazioni del gruppo, che risulterà tanto più alta quando i compiti saranno più interdipendenti.
L’Interdipendenza delle attività
Il livello di interazione richiesto ai membri di una squadra è definita da Bandura (1997): interdipendenza del compito. Questa variabile è stata distinta in task, goal ed outcome interdependence (Campion, Papper, Medsker, 1996).
L’interdipendenza del compito (task interdependence), si riferisce al grado di interazione tra i membri del gruppo nello svolgere un’attività (Shea, Guzzo, 1987). Il gruppo non è soggetto ad un modello di interdipendenza statico, ma questo varierà in funzione dei diversi meccanismi di coordinamento messi in atto dal team. Si parlerà quindi, di interdipendenza bassa (pooled task interdependence) quando un certo numero di persone svolgono il proprio compito indipendentemente le une dalle altre. In questi casi il risultato del lavoro comune è dato dalla somma degli sforzi di ciascun individuo. Nel caso invece di una catena di montaggio, troveremo un modello di interdipendenza sequenziale (sequential task interdependence), in cui l’attività di ciascun soggetto dipenderà dalla performance dei colleghi che lo precedono nelle operazioni di montaggio. Infine, in contesti in cui è necessario che i lavoratori si scambino il maggior numero di informazioni per poter svolgere al meglio il proprio compito, si parlerà di interdipendenza reciproca (reciprocal task interdependence) ed il teamwork sarà l’esempio immediato di come l’adattamento reciproco prende forma all’interno di un contesto organizzativo (Saavedra, Earley, Van Dyne, 1993; Thompson, 1967).
L’interdipendenza della meta (goal interdependence) si riferisce alle interconnessioni tra i membri di un gruppo derivanti dal tipo di obiettivo selezionato (individuale o di squadra) che guida la loro performance e dirige i loro sforzi (Saavedra et al, 1993). In particolare, gli obiettivi individuali hanno la funzione di supporto a strategie volte a massimizzare la performance individuale, mentre gli obiettivi di squadra faciliteranno lo sviluppo di strategie cooperative. A queste ultime è stata inoltre imputata una forte influenza sulla performance collettiva, e nello specifico in concomitanza di compiti altamente interdipendenti (Crown, Rosse, 1995; Mitchell, Silver, 1990).
L’interdipendenza del risultato (outcome interdependence) si riferisce all’esistenza di conseguenze e risultati condivisi dai membri della squadra. Nello specifico, è possibile che la condivisione dei risultati di una performance all’interno di un gruppo, migliori la percezione dell’efficacia di questo motivando i suoi membri a cooperare tra loro per un successo comune (Miller, Hamblin, 1963).
Sebbene, come sottolineato da Gully, Joshi, Incalcaterra e Baubien (2002), l’interdipendenza del compito, della meta e del risultato siano costrutti concettualmente distinti, è difficile separare i loro effetti, poiché nella pratica essi tendono ad essere collegati. I membri che lavorano ad un compito interdipendente (come ad esempio vincere una partita), tendono ad avere, anche mete interdipendenti (raggiungere un’alta prestazione) così come i loro risultati (ricevere lo stesso feedback e riconoscimento dall’allenatore).
Campion et al. (1996) avvalorano questa tesi ed attraverso due studi differenti hanno misurato queste tipologie di interdipendenza, concludendo che tutte e tre influenzano congiuntamente il grado in cui i membri devono lavorare insieme per operare efficacemente.
In particolare, molti studi hanno evidenziato l’importante funzione di moderatore svolta dall’interdipendenza del compito tra l’efficacia collettiva e la performance. Gully, Joshi, Incalcaterra e Baubien (2002), attribuiscono un ruolo preminente alla task interdependence nel moderare la relazione tra efficacia collettiva e prestazione, soprattutto in presenza di valori alti di interdipendenza, evidenziando quindi la grande influenza esercitata dal contesto di gruppo. Quando, infatti, il compito ed il contesto incoraggiano la collaborazione e la comunicazione tra i membri (alta interdipendenza), l’efficacia collettiva del gruppo è maggiormente correlata alla performance rispetto a quando l’interdipendenza è bassa.
La maggior parte degli studi sull’efficacia collettiva sono stati condotti in condizioni di compiti altamente interdipendenti come ad esempio in squadre sportive (Feltz et al., 1998, Zaccaro et al., 1994), o in situazioni in cui ai partecipanti era richiesto di generare, attraverso lavori di gruppo, nuove proposte (Pescosolido, 2003), o ancora in attività di resistenza muscolare in cui i componenti di una squadra dovevano tenere sulle loro teste una palla molto pesante (Bray, 2004).
In tutti questi casi un livello di interdipendenza alta favorisce l’omogeneità delle percezioni di efficacia collettiva dei membri di un gruppo, poiché quando più individui si ritrovano a dover interagire e coordinarsi tra di loro in modo interdipendente, è più facile che questi sviluppino percezioni simili sulla loro efficacia collettiva (Katz-Navon, Erez, 2005).
Tale consenso sulla propria efficacia di squadra sarà maggiore con il tempo, così come anche la capacità di ottenere prestazioni di successo aumenterà con l’esperienza (Kozlowski et al., 1999).
Il livello di interdipendenza del compito forza inoltre le interazioni tra i membri di un team e fornisce loro l’opportunità di acquisire conoscenze circa gli schemi mentali e le abilità degli altri componenti del gruppo che saranno poi fondamentali per ottenere performance di squadra migliori (Kozlowski, 1999, Cannon-Bowers, Salas, 2001).
Interessante, a tal proposito, è il contributo fornito da Katz-Navon ed Erez (2005) che esaminarono la relativa influenza dell’autoefficacia e dell’efficacia collettiva sulla performance sia individuale che di gruppo, in due situazioni parallele di alta e bassa interdipendenza del compito. Tale ricerca dimostrò che:
– l’interdipendenza del compito è in grado di facilitare l’emergere dell’efficacia collettiva di un gruppo
– in condizioni di alta interdipendenza del compito l’efficacia collettiva influenza maggiormente la performance del gruppo, mentre l’efficacia personale ha un ruolo più preminente in condizioni di bassa interdipendenza del compito
– le percezioni dell’efficacia collettiva del gruppo sono maggiormente omogenee in condizioni di alta interdipendenza del compito. Una volta che infatti i componenti di una squadra interagiscono tra loro in condizioni di alta interdipendenza, l’efficacia collettiva trascenderà dalle percezioni individuali.
Gli effetti dell’efficacia collettiva sulla prestazione sportiva
Tra le conseguenze più studiate dell’efficacia collettiva vi è sicuramente la prestazione: quanto più le convinzioni di efficacia collettiva sono elevate, tanto migliori saranno i risultati raggiunti. La relazione tra percezione di efficacia collettiva e prestazione del gruppo è stata rilevata in numerosi setting da quello educativo, a quello sportivo (Bandura, 1993, 1997; Hodges, Carron, 1992; Fernandez-Ballesteros, Diez-Nicolàs, Caprara, Barbaranelli, Bandura, 2002) ed in ricerche sul campo e in laboratorio (Felz, Lirgg, 1998; Prussia, Kinicki, 1996; Silver, Bufanio, 1996).
In ambito sportivo, la relazione tra efficacia collettiva e performance è stata evidenziata in discipline quali: hockey su ghiaccio (Mayers, Payment, Feltz, 2004), pallavolo (Spink, 1990), basket (Watson, Chemers, Preiser, 2001). Tali studi sottolineano che gruppi con percezioni di efficacia collettiva alta raggiungono performance migliori e persistono più a lungo di fronte ad ostacoli rispetto a team con bassa efficacia collettiva. È vero anche che, come descritto da Eden (1990), in condizioni di bassa efficacia collettiva un grave fallimento nella performance del gruppo – come il disastro aereo dello Space Shuttle Challenger – può contribuire ad abbassare ulteriormente la loro percezione di efficacia di squadra. Al contrario in presenza di alta efficacia collettiva, i gruppi riescono a migliorare la loro prestazione anche in seguito ad insuccessi (Hodges, Carron, 1992).
Seijts et al. (2000) e Whitney (1994), sottolineano come il gruppo con un’elevata percezione di efficacia collettiva scelga mete più difficili ed ottenga, inoltre, prestazioni migliori.
Gruppi con più alti livelli di efficacia collettiva dimostrano anche maggior impegno e motivazione (Gully, Beaubien, Incalcaterra, Joshi, 2002; Prussia, Kinicki, 1996). A tal proposito Peterson et al. (2000) suggeriscono che una bassa motivazione, riscontrata tra i membri di alcuni gruppi in una struttura burocratica, può derivare dalla percezione di una modesta relazione tra sforzi e produttività collettiva.
Le percezioni di efficacia collettiva influenzano inoltre: la forza e l’impegno nelle attività comuni, le successive prestazioni del gruppo, il tipo di futuro che le persone cercano di realizzare, la resilienza di fronte alle difficoltà e la qualità della collaborazione (Bandura, 2000a, 2000b, 2002).
Infine uno studio effettuato da Schaubroek, Lam e Xie (2000) evidenzia una forte correlazione tra l’efficacia collettiva e la capacità di affrontare situazioni stressanti. Un alto livello di efficacia attenua infatti gli effetti di malesseri psicologici e di cambiamenti nelle relazioni con altri colleghi (control-turnover relationship).
Le percezioni di contesto: il clima
Il clima all’interno di un contesto lavorativo, seppur sportivo, è comunemente definito come le percezioni diffuse di politiche organizzative, pratiche e procedure, sia a livello formale che informale, (Reichers, Schneider, 1990), è stato rilevato essere correlato significativamente con le attitudini lavorative (Glisson, Durick, 1988), il coinvolgimento lavorativo (Brown, Leigh, 1996) e la performance lavorativa (Glisson, Hemmelgarn, 1998; Pritchard, Karasick, 1973; Riketta, 2002).
Ricerche recenti hanno sottolineato, l’importanza del ruolo rivestito dalle attitudini lavorative, dalla soddisfazione e dall’organizational commitment (impegno organizzativo), nel mediare la relazione tra le percezioni di clima ed i risultati, la motivazione delle persone e la performance (Parker et al., 2003). La spiegazione a tale fenomeno risiede nella necessità delle persone di comportarsi in accordo con le proprie attitudini, aspettative e credenze relative al contesto lavorativo (Hemmelgarn, Glisson, James, 2006).
Come suggerito da James e Jones (1977), le percezioni dell’ambiente in cui operano e si allenano nel quotidiano, creano aspettative di risultato, così come i giudizi e le valutazioni di queste influenzano la motivazione a perseguire o meno nella performance.
Le attitudini e le percezioni di clima avranno, inoltre, un’influenza diretta sulla natura e sulla qualità delle interazioni in uno specifico contesto (Schneider, White, Paul, 1998). Così le persone saranno portate a manifestare sentimenti di soddisfazione ed identificazione con la propria società sportiva se il clima percepito risulta positivo. Al contrario, se in un ambiente vi è un clima non supportivo, impersonale e stressante, gli atleti instaureranno con i propri colleghi e con gli allenatori che rifletteranno il disagio causato dalla presenza di tali variabili.
È infatti più probabile che gli atleti saranno più tenaci e creativi di fronte a problemi inaspettati, se percepiscono che il loro ambiente di lavoro è giusto con loro e provvede a fornirgli un supporto individuale per i loro sforzi.
Studi sul benessere dei bambini e sul sistema di giustizia minorile hanno avvalorato queste tesi (Glisson, Durick, 1988; Glisson, Hemmelgarn, 1998; Glisson, James, 2002). Appare infatti evidente che, per raggiungere risultati di successo in tali contesti di lavoro, si ha bisogno di assistenti sociali capaci di reagire a problemi inaspettati e necessità individuali, tenaci nell’affrontare il labirinto di una burocrazia complessa ed abili nell’ instaurare relazioni personali che ottengano la fiducia e la confidenza con i bambini e le loro famiglie. In presenza di percezioni di clima positive gli assistenti sociali saranno portati naturalmente a fornire assistenza con alti livelli di responsabilità e disponibilità ai bambini che seguono, accrescendo, inoltre, la loro stessa percezione di soddisfazione lavorativa ed impegno organizzativo. Allo stesso modo, i bambini seguiti da agenti in un clima più positivo, saranno più probabilmente portati a migliorare il loro atteggiamento psicosociale, ottenendo una più ampia collaborazione e continuità nell’assistenza fornita dal sistema giudiziario (Glisson, Hemmelgarn, 1998).
Aron e Milicic (2000), attraverso la loro ricerca condotta su insegnati cileni, evidenziano come relazioni con il preside e con il corpo docente insoddisfacenti, a causa della poca comunicazione, di retribuzioni insufficienti, sovraccarico di lavoro e situazioni di insegnamento non idonee, diano vita a sentimenti di burnout (stato di elevato stress psico-fisico).
Un altro importante fattore da considerare tra le dimensioni del clima è la percezione del leader. A tal proposito, Chen e Bliese (2002) prendono in considerazione la leadership e la definiscono come “una variabile condivisa a livello di gruppo che riflette le percezioni del team riguardanti sia il grado in cui i leaders sono orientati al compito sia le modalità con cui forniscono il supporto socio emotivo ai subordinati” (p. 549).
Hofmann, Morgeson e Gerras (2003), evidenziano, inoltre, l’importanza del clima organizzativo nel mediare la relazione tra il leader ed i componenti di una squadra, soprattutto in quei contesti in cui si instaurano climi positivi e dove gli atleti percepiscono come insito nel loro ruolo, investire energie nella performance. Ciò avviene perché quando la persona percepisce un clima positivo, sente la necessità di ricambiare con relazioni di alta qualità che producano benefici sia al leader che all’ambiente di lavoro (Blau, 1964; Gouldner, 1960).
Relazione tra clima ed efficacia collettiva
Numerose ricerche hanno collegato il clima all’efficacia collettiva: Russell (2002), propone un modello di “causazione reciproca collettiva” in cui i fattori concernenti il gruppo, quali rapporti interpersonali, le rappresentazioni cognitive e lo stesso ambiente, determinano il clima psicologico che influenzerà l’efficacia collettiva che a sua volta avrà effetto sulla performance del gruppo.
Mackenzie (2001), dall’analisi della relazione tra le percezioni di clima in un contesto accademico e le convinzioni di efficacia collettiva del corpo docente, sottolinea una correlazione positiva tra i due costrutti, in situazioni in cui gli obiettivi sono condivisi ed associati ad un senso di collegialità. Tale correlazione risulta, invece, meno positiva quando i compiti richiedono un lavoro di gruppo.
Chen e Bliese (2002), suggeriscono inoltre che il clima di leadership è più significativamente correlato all’efficacia collettiva rispetto all’autoefficacia, questo perché è direttamente associato alla motivazione del gruppo di lavoro, piuttosto che a quella dei singoli membri. Tali risultati confermano il concetto che i leaders sono più focalizzati sul miglioramento della performance dei loro gruppi nell’insieme piuttosto che aumentare la performance dei membri singoli della squadra.
Conclusioni aperte
Lo sport dovrebbe essere valorizzato come strumento al servizio della crescita dell’individuo, della sua autonomia e del suo senso di autoefficacia, al contrario, oggi è divenuto scorciatoia per raggiungere un senso, spesso illusorio, di stabile identità, ed è sempre maggiormente subordinato all’esigenza di vincere a tutti i costi, non con lo scopo di fornire rinforzo alla propria autoefficacia, ma solo per ottenere visibilità sociale. (Trabucchi, 2003).
Diventa quindi pericoloso lasciar passare unicamente il messaggio “competi solo per vincere”, poiché in questo modo si amplifica nell’atleta la paura della sconfitta ed aumenta l’ansia connessa con la prestazione, andando così ad influire negativamente, direttamente sulla motivazione alla base della pratica sportiva.
Ciò che è importante fare è trasmettere ai giovani il piacere della sfida con se stessi, facendo in modo che lo sport venga considerato come un mezzo per superare i propri limiti e per acquisire capacità di self-challange. L’atleta va educato ad attribuire alla vittoria un valore perché connesso con il raggiungimento dei propri obiettivi, piuttosto che, per la sconfitta dell’avversario. Questo atteggiamento permette il consolidamento della motivazione ed è quindi garanzia che la pratica sportiva duri anche quando le prestazioni potranno avere periodi di calo.
Lo sport fornisce l’occasione per accrescere il proprio senso di autoefficacia ed è il possesso di questa che consentirà all’agonista di affrontare allenamenti duri, superare le frustrazioni e durare nel tempo anche se non arrivano velocemente i risultati sperati, vivendo lo sport come un piacere ed un “lavoro creativo”, invece di una costrizione nevrotica o una punizione camuffata da premio (Trabucchi, 2003).
Una serie di insuccessi può, tuttavia, indebolire la convinzione della propria efficacia, creando una crisi prestazionale negli atleti che, a causa delle loro insicurezze, non saranno incentivati ad investire il dovuto impegno nell’attività agonistica, facendosi più facilmente sopraffare dalle ansie e dalle paure nei momenti di maggiore pressione. E’ in questa fase che nasce la necessità di un intervento mirato a far si che gli atleti siano capaci di fronteggiare in modo adattivo gli insuccessi, poiché gli errori e le sconfitte danno vita a pensieri negativi che vanno ad incidere a cascata sulle future prestazioni. Compito del controllo cognitivo, che deve essere attivato dall’individuo, è quindi fermare le rimuginazioni sui fallimenti, concentrando l’attenzione sul presente, sul compito e sull’obiettivo prefissato, evitando di prendere in considerazione pensieri non costruttivi e quindi debilitanti.
Con gli atleti demotivati occorre spezzare il circolo negativo che si crea tra la debole sensazione di competenza, le basse aspettative (causate dagli insuccessi precedenti) e lo scarso rendimento in allenamento ed in gara. Le convinzioni di autoefficacia, come già detto, influenzano i modi in cui gli individui approcciano alle sfide: un’atleta che non è in grado di eseguire un determinato gesto atletico è improbabile che affronti con entusiasmo una nuova serie di esercizi, diventando, al contrario, ansioso e demotivato.
Cruciale è quindi il comportamento dell’allenatore, come sottolineato da Deci (1975) e Frederick e Ryan (1995): il coach dovrà proteggere ed incentivare in primis la motivazione intrinseca dell’atleta, e per fare questo dovrà indirizzare i suoi sforzi a valorizzare e fortificare il senso di efficacia del suo allievo, rinforzando prevalentemente la responsabilizzazione, l’autoregolazione e la partecipazione. Dovrà, poi, essere attento al significato dei rinforzi materiali e simbolici e dei messaggi, feedback, che invia più o meno consapevolmente.
È importante, a tal proposito, distinguere tra feedback intrinseco, insieme delle informazioni provenienti dal sistema sensoriale di chi esegue il movimento, percezioni che il soggetto è in grado di ricevere ed elaborare grazie ai suoi analizzatori (visivo, cinestesico tattile, acustico e vestibolare); ed il feedback estrinseco, insieme delle informazioni derivanti dal sistema sensoriale di chi osserva il movimento, proveniente quindi da fonti esterne come l’allenatore, ed arriva al soggetto attraverso canali verbali e para-verbali. In particolare, per quanto riguarda quest’ultima modalità di feedback, è fondamentale che in qualche modo venga “tradotto” in un linguaggio motorio, ovvero le informazioni visive ed acustiche devono integrarsi con quelle vestibolari e propriocettive del feedback intrinseco percepito dall’atleta. Da qui la necessità da parte dell’allenatore di far riferire i propri feedback esterni a quelli interni dell’allievo e di trovare quindi gesti e parole che facilitino tale comunicazione, permettendo all’atleta di collegare le istruzioni verbali dell’allenatore con le proprie sensazioni motorie (Mantovani, 2004).
Secondo Magill (1980), il feedback estrinseco dell’allenatore svolge sempre una duplice funzione: a) informativa; b) di rinforzo. La funzione informativa riguarda quanto già si è detto circa le informazioni che l’allenatore rende disponibili per l’allievo, affinché questi possa collegarle alle proprie percezioni interne, per meglio controllare i propri movimenti e raggiungere livelli di efficacia del gesto sempre maggiori. La funzione di rinforzo, riguarda invece, l’effetto che qualsiasi feedback dell’allenatore produce sulla sfera emotiva dell’atleta: ogni azione del coach comporta una ricaduta sulla sua motivazione, disponibilità ad agire ed autostima. In uno stesso feedback è facile che coesistano entrambe le funzioni ed è per questo motivo che questo aspetto produce effetti importanti sul piano relazionale ed influenza il rapporto allenatore-atleta.
A questo punto è importante chiedersi come debba essere esplicitato un feedback affinché rientri in un circuito di comunicazione efficace, e quindi essere accettato, condiviso ed appreso dall’allievo?
Hanke e Woermann (1993), hanno individuato nella precisione, modalità, frequenza e scelta del tempo le dimensioni che ne definiscono l’efficacia. Le informazioni devono essere, infatti, tempestive e molto specifiche: quando la frequenza di informazioni è eccessiva o il contenuto del messaggio è superiore alla capacità di elaborazione dell’atleta, l’effetto dei feedback può essere limitato.
A tal proposito, Baraldo e Bortoli (2004), hanno fornito alcune importanti indicazioni che ogni allenatore dovrebbe seguire:
- Fornire indicazioni in modo frequente in una prima fase di apprendimento o quando il compito non è stato compreso.
- Ridurre gradualmente il feedback estrinseco al progredire dell’apprendimento.
- Correggere gli errori uno alla volta a partire da quelli più rilevanti.
- Permettere che l’atleta corregga immediatamente dopo l’esecuzione l’errore segnalato.
- Fornire istruzioni in positivo.
- Utilizzare parole stimolo e brevi frasi per richiamare l’azione corretta.
- Coinvolgere l’atleta con domande volte ad analizzare e discutere la prestazione propria o di un compagno.
- Utilizzare incoraggiamenti per innalzare la motivazione.
È importante, infine, sottolineare che, ad influire sulla motivazione dell’atleta e sulla sua percezione di autoefficacia, non sono solo i feedback provenienti dal proprio allenatore, ma notevole importanza acquistano quelli dei propri pari, compagni o colleghi, così come quelli provenienti dall’ambiente esterno o utilizzando strumenti come l’apparecchiatura di biofeedback, in grado di fornire informazioni sensoriali di ritorno al soggetto con lo scopo di produrre modificazioni al suo comportamento.
Il Biofeedback (retro-informazione biologica) consente, collegandosi all’organismo umano attraverso dei sensori, di porre sotto controllo volontario funzioni corporee normalmente al di fuori della consapevolezza e dell’intenzione volontaria (Anchisi, Gambotto, 1996).
La tecnica del Biofeedback, nonostante il crescente interesse da parte dei ricercatori, è ancora poco utilizzata nel mondo dello sport perché poco conosciuta. Ciò probabilmente è dovuto alla non conoscenza da parte di allenatori ed atleti dell’importanza e delle potenzialità che potrebbe avere nei programmi di allenamento.
Tramite tale strumento, infatti, psicologi o medici esperti, con l’applicazione di elettrodi o di trasduttori sulla pelle che colleghino la macchina e l’individuo, possono guidare il proprio paziente a modificare risposte cognitive, motorie e neurovegetative disregolate. Il miglioramento è possibile perché il Biofeedback fornisce al soggetto informazioni sui suoi processi fisiologici, amplificati e tradotti in segnali percepibili sensorialmente, consentendo così di ottenere consapevolezza dei propri stati interni e facilitando i meccanismi di autoregolazione ed autocontrollo delle variabili fisiologiche coinvolte. Quest’ultime vengono tradotte in segnali acustici o visivi, proporzionali alla loro intensità, permettendo al soggetto sottoposto alla procedura, di avere una percezione immediata delle proprie condizioni biologiche (Manili, Ferrari, 2002).
Concludendo, è evidente, grazie anche alla numerosa letteratura e le ricerche esistenti, il ruolo centrale giocato dalle percezioni di efficacia personale e collettiva nella prevenzione dell’abbandono dell’attività sportiva e nel rafforzamento della motivazione a perseguire, così come l’importanza di fornire feedback adeguati per rinforzare e consolidare le percezioni di efficacia degli individui. Risultano, tuttavia, ancora pochi gli studi che si sono occupati di monitorare l’influenza che potrebbe avere l’utilizzo del biofeedback sulle future prestazioni sportive e conseguentemente sull’autoefficacia, efficacia collettiva e sulla motivazione dell’atleta.
Quanto uno strumento che porta al decremento dei livelli di stress fisiologici e psicologici in un’atleta (Blumenstein, Bar-Eli, Tenenbaum, 2002), può influire sulla sua prestazione e sulle sue convinzioni di efficacia, può essere efficace a prevenire l’abbandono sportivo e quindi influire sulla motivazione intrinseca ad investire nella propria attività agonistica?
Lasciamo aperta la discussione, in attesa di poter monitorare sul campo tale relazione.
Bibliografia
- Alderman, R.B., e Wood, N.L. (1976): An analysis of incentive motivation in young Canadian athletes – “Canadian Journal of Applied Sport Sciences”, 1(2), pp. 169-175
- Anchisi, R., Gambotto, D.M., (1996): Manuale di biofeedback psicologia e medicina comportamentale – Edizione Libreria Cortina Torino
- Aron, A.M., Milicic, N., (2000): Teachers’ burnout and school social climate/Desgaste professional de los profesores y clima social escolar – Revista Latinoamericana de Psicologia, 32, 3, 447-466
- Baltes, M.M., (1996): The many faces of dependency in old age – New Yourk: Cambridge University Press
- Bandura, A, (1999): Social Cognitive Theory of Personality – In L.Pervin, O. John (eds.), Handbook of Personality, Guilford, New York
- Bandura, A, Locke, E.A., (2003): Negative Self-Efficacy and Goal Effects Revisited – Journal of Applied Psychology, 1, 87-99
- Bandura, A. e Cervone, D. (1983): Self-evaluative and self-efficacy mechanisms governing the motivational effects of goal systems – “Journal of Personality and Social Psychology”, 45, pp. 1017-1028.
- Bandura, A., (1962): Social learning through imitation – In M.R. Jones (ed.), Nebraska Symposium on Motivation, University of Nebraska Press, Lincoln
- Bandura, A., (1977): Social Lerning Theory, Englewood Cliffs – New Jersey, Prentice Hall
- Bandura, A., (1986): Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory – Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall
- Bandura, A., (1989): Human Agency in Social Cognitive Theory – American Psycologist, 44, 1175-1184
- Bandura, A., (1991): Self-regulation of motivation through anticipatory and self-reactive mechanisms – In Perspectives on Motivation: Nebraska Symposium on Motivation, RA Dienstbier, Lincoln Univ.Nebraska Press, 38:69-164
- Bandura, A., (1990): Perceived self efficacy in the exercise of personal agency – Journal of Applied psychology, 2, 128-163
- Bandura, A., (1993): Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning – Educational Psychologist, 28, 117-148
- Bandura, A., (1997): Self-efficacy: The exercise of control – New York: Freeman
- Bandura, A., (2000a): Autoefficacia – Erickson, Trento
- Bandura, A., (2000b): Exercise of Human Agency Through Collettive Efficacy, Current Directions – in Psychological Science, 9, 3, 75-78
- Bandura, A., (2001): Social Cognitive Theory: An agentic perspective – Annual Review of Psychology, 52, 1-26
- Bandura, A., (2002): Social cognitive theory in cultural context – Journal of Applied Psychology: an International Review, 51, 269-290
- Bandura, A., (2006): Towards a psychology of human agency – Perspectives on Psychological Science, 1
- Bandura, A., Locke, E.A., (2002): Growing primacy of human agency in adaptation and change in electronic era – European Psychologist, 7, 2-16
- Baraldo, L., Bortoli, L. (2004): L’uso del feedback informativo nella tecnica sportiva – AtleticaStudi, vol. 1, pp. 39-44
- Bass, B.M., (1985): Leadership and Performance Beyond Expectations – Free Press, New York
- Benedetti, S., Landi, S., Merola, G. (2006): Lo psicologo delle sport nella scuola calcio – Edizioni Luigi Pozzi, Roma
- Blau, P., (1964): Exchange and power in social life – New York: Wiley
- Blumenstein, B., Bar-Eli, M., Tenenbaum, G. (2002): Biofeedback Application in Performance Enhancement – Brain and Body – in Sport Exercise, John Wiley & sons, Chichester, UK
- Borgogni, L., (2001): Efficacia organizzativa – Guerini studio
- Borgogni, L., (2002): Valutazione e motivazione delle risorse umane nelle organizzazioni – Milano, Franco Angeli
- Borgogni, L., Petitta, L., (2003): Lo sviluppo delle persone nelle organizzazioni – Carocci, p 68
- Brandstadter, J., (1992): Personal control over development: implications of self efficacy – In R. Schwarzer, (ed.), Self efficacy: Thought Control of Action – Washington, DC: Hemisphere, 127-145
- Bray, S.R., (2004): Collective efficacy, group goals, and group performance of muscular endurance task – Small Group Research, 35, 230-238
- Brody, E.B., Hatfield, B.D. e Spalding, T.W. (1988): Generalization of self-efficacy to a continuum of stressors upon mastery of a high-risk sport skill – “Journal of Sport & Exercise Psychology”, 10, pp. 32-44.
- Brown, S.P., Leigh, T.W., (1996): A new look at psychological climate and its relationship to job involvement effort, and performance – Journal of Applied Psychology, 81, 358-368
- Campion, M.A., Papper, E.M., Medsker, G.J., (1996): Relations between work team characteristics and effectiveness: A replication and extension – Personnel Psychology, 49, 429-452
- Cannon-Bowers, J.A., Salas, E., (2001): Reflections on shared cognition – Journal of Organizational Behavior, 22, 195-202
- Caprara, G.V., (2000): L’efficacia collettiva – Psicologia Contemporanea, 159, 34-39
- Caprara, G.V., Borgogni, L., Barbaranelli, C., Rubinacci, A., (1999): Convinzioni di efficacia e cambiamento organizzativo – Sviluppo & Organizzazione 174, 19-32
- Cei, A., (1998): Psicologia dello sport – Bologna, Il Mulino
- Chambliss, C.A., Murray, E.J., (1979a): Cognitive procedures for smoking reduction: Symptom attribution versus efficacy attribution – Cognitive Therapy and Research, 3, 91-96
- Chambliss, C.A., Murray, E.J., (1979b): Efficacy attribution, locus of control, and weight loss – Cognitive Therapy and Research, 3, 349-350
- Chen, G., Bliese, P.D., (2002): The role of different levels of leadership in predicting self and collective efficacy: evidence for discontinuity – Journal of Applied Psychology, 87, 549-556
- Crown, D.F., Rosse, J.G., (1995): Yours, mine and ours: Facilitating group productivity through the integration of individual group goals – Praganizational Behavior & Human Decision processes, 64, 138-150
- Deci, E.L., (1975): Instrinsic motivation – New York, Plenum Press
- Duda, J.L., Whitehead, J., (1992): Measurement of goal perspectives in the physical domain – In Duda J.L (Ed), Advances in sports and exercise psychology measurement, Morgantown, WV, Fitness Information Technology
- Eden, D., (1990): Pygmalion in management – Lexington, MA: Lexington Books
- Eden, D., Shani, A.B., (1982): Pygmalion goes to boot camp: Expectancy, leadership and trainee performance – Journal of Applied psychology, 67, 194-199
- Feather, N.T., (1982): Expectations and Actions: Expetacy-Value Models – in Psychology, Hillsdale, NJ: Erlbaum
- Feltz, D. L., Riessinger, C.A., (1990): Effects of in vivo emotive imagery and performance feedback on self-efficacy and muscular endurance – Journal of Sport & Exercise Psychology, 12 (2), pp.132-143
- Feltz, D.L., Lirgg, C.D., (1998): Perceived team and player efficacy in hockey – Journal of Applied Psychology, 83, 557-564
- Fernandez-Ballestreros, R., Diez-Nicolas, J., Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Bandura, A., (2002): Determinants and structural relation of personal efficacy to collective efficacy – Applied Psychology: An international Review, 51, 107-125
- Fitzsimmons, P. A., Landers, D. M., Thomas, J. R., & van der Mars, H. (1991): Does self-efficacy predict performance in experienced weightlifters? – Research Quarterly for Exercise and Sport, 62, 424-431.
- Frederick, C.M., (1995): Self-determination in sport: A Review Using Cognitive Evaluation Theory – International Journal of Sport Psychology, 20, pp. 256-278
- George, T. R., Feltz, D. L., & Chase, M. A. (1992): The effects of model similarity on self-efficacy and muscular endurance: A second look – Journal of Sport and Exercise Psychology, 14, 237-248.
- Gibson, C.B., (1995): Determinats and Consequences of Group-Efficacy Belief in Work Organization in US, Hong Kong, and Indonesia – PhD diss, University of California, Irvine
- Gibson, C.B., (2003): The efficacy advantage: Factors related to the formation of group efficacy– Journal of Applied Social Psychology, 33, 2153-2186
- Gill, D.L., Gross, J.B. e Huddleston, S. (1983): Partecipation Motivation in Youth Sport – “International Jourmal of Sport Psychology”, 14, pp.1-14.
- Glisson, C., Durick, M., (1988): Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service organizations – Administrative Science Quarterly, 33, 61-81
- Glisson, C., Hemmelgarn, A.L., (1998): The effects of organizational climate in human service team and interorganizational coordination on the quality and outcomes of children’s service systems – Child Abuse and Neglect, 22(5), 401-421
- Goddard, R.D., Goddard, Y.L., (2001): A multilevel analysis of the relationship between teacher and collective efficacy in urban schools – Teaching & Teacher Education, 17, 807-818
- Goddard, R.D., Hoy, W.K.; Hoy, A.W., (2004): Collective Efficacy: Theoretical Developments, Empirical Evidence, and Future Directions – Educational Researcher, 33(8), 3-13
- Gould, D., Feltz, D., Horn, T.S, Weiss, M.R., (1982): Reasons for attrition in competitive youth swimming – Journal of Sport Behavior, vol. 5, pp. 155-165
- Gouldner, A.W., (1960): The norm of reciprocy – American Sociological Review, 25, 165-167
- Gully, S.M., Incalcaterra, K.A., Joshi, A., Beaubien, J.M., (2002): A meta-analysis of team-efficacy, potency, and performance: interdependence and level of analysis as moderators of observed relationships – Journal of Applied Psychology, 87, pp. 819-832
- Hanke, U., Woermann, S., (1993): Trainerwissen, Koln, Straub – tratto da Benedetti, S., Landi, S., Merola, G. (2006), Lo psicologo delle sport nella scuola calcio, Edizioni Luigi Pozzi, Roma
- Hemmelgarn, A.L, Glisson, C., James, L.R., (2006): Organizational Culture and Climate: Implications for Service and Interventions Research – Clinic Psychologist Practice, University of Tennessee, TN, 13, 73-89
- Hodges, L., Carron, A.V., (1992): Collective efficacy and group performance – International Journal of Sport Psychology, 23, 48-59
- Hoffmann, D.A., Gerras, S.J, Morgeson, F.P., (2003): Climate as a Moderator of the Relationship Between leader-member Exchange and Content Specific Citizenship: Safety Climate as an Exemplar – Journal of Applied Psychology, 88, 1, 170-178
- Holden, G., Moncher, M.S., Schinke, S.P., Barker, K.M., (1990): Self efficacy of children adolescents: A meta-analysis – Psychological Reports, 66, 1044-1046
- Holloway, J.B., Beuter, A., Duda, J.L., (1988): Self-efficacy and Training for Strength in Adolescent Girl – Journal of Applied Social Psychology, 18, 8, pp. 699-719
- Howell, J.M., Frost, P.J., (1989): A Laboratory Study of Charismatic Leadership – Organizational Behavior and Human Decision processes, 43, 243-269
- Hoyt, C.L., Halverson, S.K., Murphy, S.E., Watson, C.B., (2003): Group Leadership: Efficacy and Effectiveness – Group Dynamics: Theory, Research and Practice, vol.7, 4, 259-274
- Istat, (2005): Lo sport che cambia, I comportamenti emergenti e le nuove tendenze della pratica sportiva in Italia – Collana Informazioni n.29. p.9
- James, L.A., Jones, A.P., (1974): Organizational Climate: A Review of Theory and Research – Psychological Bullettin, 97, pp. 251-273
- Katz, T., Erez, M., (2005): Collective efficacy and self efficacy in the context of high and low task interdependence – Small Group Research, 36, 437- 465
- Kozlowski, S.W.J., Gully, S.M., Nason, E.R., Smith, E.M., (1999): Developing adaptive teams: A Theory of compilation and performance across levels and time – In D.R. Ilgen and E.D. Pulakos (Eds.): The Changing nature of performance: Implications for staffing, motivation, and development, (pp.240-292), San Francisco: Jossey-Bass
- Lindsley, D.H., Brass, D.J., Thomas, J.B., (1995): Efficacy-performance Spirals: a Multilivel Perspective – Accademy of Management Review, 20, 645-678
- Locke, E.A., Lathan, G.P., (1990): A Theory of Goal Setting and Task Performance – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
- Lucas, W., Cooper, S., (2005): Measuring Entrepreneurial self efficacy – A paper prepared for the EDGE conference 11-13th July, Singapore, 2-25
- MacKenzie, S., (2001): Collective efficacy and collaborative climate in maine high schools – Dissertation Abstract International Science A: Humanities & Social Sciences, 61(9-A), 3426 (solo abstract)
- Magill, R.A., (1980): Motor learning – Dubuque.
- Manili, U., Ferrari, M., (2002): L’applicazione del biofeedback nella psicofisiologia dello sport e nell’allenamento – Movimento,vol. 8 n.2 maggio-agosto, Ed. L. Pozzi
- Mantovani, C., (2004): Feedback and motor control systems – Italian Journal of Sport, vol 1, pp. 23-27
- Martens, R., (1987): Coaches guide to sport psychology – Champaign, IL, Human Kinetics
- Mayers, N.D, Payment, C.A., Feltz, D.L., (2004): Reciprocal Relationships Between Collective Efficacy and Team performance in Women’s Ice Hockey – Group Dynamics: Theory, Research and Practice, vol.8, 3, 182-195
- McAuley, E. (1985): Modeling and self-efficacy: A test of Bandura’s model – “Journal of Sport Psychology”, 7, pp. 283-295.
- McPherson, B., (1980): The social sistem of age group swimmers: the perception of swimmers, parents and coaches – Canadian Journal of Applied Sport Science, vol. 3 , pp. 142-145
- Miller, L.K., Hamblin, R.I., (1963): Interdependence, differential rewarding, and productivity – American Sociological Review, 28, 768-778
- Mitchell, T.R., Silver, W.S., (1990): Individual and group goals when workers are interdependent: Effects on task strategies and performance – Journal of Applied Psychology, 75, 185-193
- Moritz, S.E., Feltz, D.L., Fahrbach, K.R., Mack, D.E., (2000): The relation of self efficacy measures to sport performance: a meta-analytic review – Research Quarterly for Exercise and Sport, 71, 280-294
- Multon, K. D., Brown, S. D., Lent, R. W. (1991): Relation of self-efficacy beliefs to academic- outcomes: A meta-analytic investigation – Journal of Counseling Psychology , 38, pp. 30-38
- Orlick, T.D., (1973): Children’s sports: a revolution is coming – Canadian Association for Health, Physical education and Recreation Journal, vol. 39, pp. 12-14
- Pajares, F., (2002): Overview of social cognitive theory and of self-efficacy – from http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html
- Parker, C.P., Baltes, B.B., Young, S.A., Huff, J.W., Altmann, R.A., Lacost, H.A., et al (2003): Relationships between psychological climate perceptions and work out-comes: A meta-analytic review – Journal of Organizational Behavior, 24, 389-416
- Pescosolido, A.T., (2001): Informal leaders and the development of group efficacy – Small group Research, 32, 74-93
- Pescosolido, A.T., (2003): Group efficacy and group effectiveness: The effects of group efficacy over time on group performance and development – Small Group Reserch, 34, 20-42
- Peterson, E., Mitchell, T.R., Thompson, L., Burr, R., (2000): Collective efficacy and aspects of shared mental models as predictors of performance over time in work groups – Group Processes and Intergroup Relations, 3, 296-316
- Pooley, J.C., (1981): Drop-outs from sport: A case study of boy’s age-group soccer – AAHPER Conference, Boston
- Pritchard, R.D., Karasick, B.W., (1973): The effects of organizational climate on managerial job performance and job satisfaction – Organizational Behavior and Human Performance, 9, 126-146
- Prussia, G.E., Kinicki, A.J., (1996): A motivational Investigation of Group Effectiveness Using Social – Cognitive Theory – Journal of Applied Psychology, 81, 187-198
- Quaglino, G.P, (1995): Clima organizzativo e qualità delle relazioni interne – Sviluppo & Organizzazione, 147, 31-47
- Quaglino, G.P., Mander, B., (1987): I Climi Organizzativi – il Mulino, Bologna
- Reichers, A. E., & Schneider, B. (1990): Climate and culture: An evolution of constructs – In B. Schneider (Ed.), Organizational climate and culture, San Francisco: Jossey-Bass. pp. 5–39
- Riketta, M., (2002): Attitudinal organizational commitment and job performance: a meta-analysis – Journal of Organizational Behavior, 23, 257-266
- Rosenthal, R., Jacobson, L., (1968): Pygmalion in the classroom – New York: Holt, Rinehart & Winston
- Russell, L.J., (2002): Collective reciprocal causation: A model of the relationships among group behaviour, group environment, group cognition and group effectiveness – Dissertation Abstracts International Section A: Humanities & Social Sciences, 63 (2-A), 668 (solo abstract)
- Saavedra, R., Early, P.C., Van Dyne, L., (1993): Complex interdependence in task-performing groups – Journal of Applied Psychology, 78(1), 61-72
- Sadri, G., Robertson, I.T., (1993): Self efficacy and work-related behaviour: A review and meta-analysis – Applied Psychology: An International Review, 42, 139-152
- Sapp, M., Haubenstricker, R.J, (1978): Motivation for Joining and Reasons for not Continuing in Youth Sport Programs in Michigan – AAHPER Conference, Kansas City, Mo
- Schaubroeck, J., Lam, S.S.K., Xie, J.L., (2000): Collective efficacy versus self efficacy in coping responses to stressors and control: A Cross-Cultural study – Journal of Applied Psychology, 85, 512 – 525
- Schneider, B., White, S.S., Paul, M.C., (1998): Linking service climate and customer perceptions of service quality: Test of a casual model – Journal of Applied Psychology, 83(2), 150-163
- Schunk, D.H., Cox, P.D., (1986): Strategy training and attributional feedback with learning disabled students – Journal of Educational Psychology, 78, 201-209
- Schwarzer, R., Schmitz, G.S., (2004): Perceived self efficacy and teacher burnout: a longitudinal study in ten schools – Research paper, Freie Universitat Berlin, Germany, 22-25
- Seijts, G.H., Latham, G.P., Whyte, G., (2000): Effects of self-and group performance in a mixed-motive situation – Human Performance, 13(3), 279-298
- Shea, G.P., Guzzo, R.A., (1987): Groups as human resources – In Rowland, K. M., Ferris, G.R., (Eds), Research in human resources and personal management, Greenwich , CT, JAI PRESS, vol. 5, pp. 323-356
- Silver, W.S., Bufanio, K.M., (1996): The impact of group efficacy and group goal on group task performance – Small Group Research, 27, 347-359
- Spink, K.S., (1990): Group cohesion and collective efficacy of volleyball teams – Journal of Sport & Exercise Psychology, 12, 301-311
- Stajkovic, A.D., Luthans, F., (1998): Self-efficacy and work related performance: a meta-analysis – Psychological Bullettin, 123, pp. 1-20
- Stajkovic, A.D., Lee, D.S., (2001): A meta-analysis of the relationship between collective efficacy and group performance – Paper presented at the National Academy of Management Meeting, Washington, DC
- Steca, P., (2011): Le convinzioni di efficacia personale e collettiva nello sport – Dalla valutazione al potenziamento – in SportivaMente, Temi di Psicologia dello Sport, autori vari, Ed. Universitarie di Lettere Economia Diritto, a cura di Lucidi F.
- Thompson, J.D., (1967): Organizations in action – New York: McGraw-Hill
- Trabucchi, P. (2003): Ripensare lo sport – Franco Angeli, Milano
- Watson, C.B., Chemers, M.M., Preiser, N., (2001): Collective efficacy: A multilevel analysis – Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1056-1068
- Weinberg, R.S., Jackson, A., (1990): Building self-efficacy in tennsi players: a coach’s perspective – Journal of Applied Sport Psychology, 2, pp. 164-174
- Weldon, E., Weingart, L.R., (1993): Group Goals and Group Performance – British Journal of Social Psychology, 32, 4, 307-334
- Whitney, K., (1994): Improving group task performance: The role of group goals and group efficacy – Human Performance, 7(1), 55-78
- Wood, R.E., Atkins, P., Tabernero, C., (2000): Self efficacy and Strategy on complex Tasks – Applied Psychology: An International Review, 49, 430-46
- Yukl, G.A., (1984): Leadership in Organizazions – Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ)
- Zaccaro, S.J., Blair, V., Peterson, C., Zazanis, M., (1995): Collective Efficacy – In J.E. Maddux (Ed.), Self-efficacy, adaption, and adjustment theory, research and application, New York: plenum press, pp.305-328
Umberto Manili
Psicologo dello Sport – Coordinatore Settore Psicologia Istituto Medicina e Scienza dello Sport – C.O.N.I.
Miriam Palange
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologico Sociali di intervento nel lavoro, nelle organizzazioni e nelle istituzioni
**
Recent Posts
Come creare un piano efficace per allenarsi a casa?
Allenarsi a casa sta diventando sempre più popolare grazie alla sua comodità e flessibilità. Questa…
Kick Boxing – Dalla Storia Ad Oggi
Kick Boxing - uno sport che combina tecniche di pugilato con calci e ginocchiate. È…
Integratori: sempre più efficaci per il benessere di muscoli e ossa
Quando si fa sport, a seconda della tipologia di attività sono diverse le parti del…
Lo Sport è il Graal del Buonumore
Praticare allenamento e sport è un modo per migliorare la salute e mantenersi in forma.…
Spinning – Benefici e Allenamento di Indoor Cycling
Spinning - Forma Fisica e Divertimento Lo Spinning è una delle discipline che nel corso…
Antibiotico per denti e sport: l’importanza della salute orale
Non importa se sei un professionista o un dilettante, le infezioni orali influenzano negativamente le…